La scomparsa di Giovanna Marini ha fatto troppo poco rumore, lei che alla musica ha dedicato tutta la vita, lei che affermava sicura che non esistono persone stonate, lei che era generosa di sé e della sua vastissima esperienza.
Un piccolo, ma significativo omaggio è comparso su la Repubblica il 10 maggio scorso, a firma di Concita De Gregorio che la conosceva bene e che racconta «minuzie senza importanza»; in realtà sono ben altro e tratteggiano con efficacia un modo di essere e di condividere. Ma vediàmole queste “minuzie” tanto significative. Quella volta, ad esempio, che con il fazzoletto rosso al collo si mise a dirigere il coro delle Mani Bianche di Udine, quello cioè di bambini e bambine non udenti che tuttavia percepiscono benissimo le vibrazioni e vedono i colori, e lì, al teatro Olimpico, cantavano, gesticolavano a tempo e ridevano. Oppure quell’altra volta vicino ad Arezzo, quando fece intonare Maremma amara anche a chi affermava di non saper cantare: «non lo devi saper fare, viene da solo», disse. Quando un giorno le fu chiesta un’intervista, stupita, si domandava cosa mai avrebbe potuto dire. Ma forse l’episodio più bello è il prossimo: una sera faceva freddo, sui colli romani, e arrivò una telefonata dalla scuola del quartiere Testaccio, dove teneva regolarmente lezione. Fu avvertita che ci sarebbe stata solo un’allieva e le domandavano se preferiva annullare; lei ribatté subito: «Perché mai?». De Gregorio conclude: «Un’artista immensa. Ma un essere umano incommensurabile, prima». Ecco, questa è stata Giovanna Marini.
Era nata il 19 gennaio 1937 a Roma, dove ha vissuto e dove è morta lo scorso 8 maggio; la sua era una famiglia di musicisti: il padre un compositore, Giovanni Salviucci, scomparso a soli trent’anni, subito dopo la nascita della figlia che si dimostrò portata per la musica e frequentò il Conservatorio di Santa Cecilia. Nel 1959 si diplomò in chitarra classica e si perfezionò con il grandissimo Andrés Segovia. Approfondì poi gli studi degli strumenti a corda, e del liuto in particolare che suonò nel Concentus Antiqui guidato dal maestro Carlo Quaranta. Fu allora che cominciò a utilizzare il cognome Marini, avendo sposato il fisico nucleare Pino Marini, con cui brevemente visse a Boston. Da questa esperienza nacque nel 1966 un album dal titolo Vi parlo dell’America.
A Roma cominciò a frequentare alcuni dei massimi intellettuali del momento con cui ebbe fruttuose collaborazioni: Pasolini e Calvino, ma anche musicisti, antropologi e ricercatori come Roberto Leydi, Gianni Bosio, Diego Carpitella, Alberto Mario Cirese e altri. Un evento significativo che la vide fra i protagonisti avvenne al Festival dei Due Mondi di Spoleto, nel 1964, a cui partecipò con il celebre gruppo Nuovo Canzoniere Italiano, che era stato fondato a Milano due anni prima. Avevano preparato uno spettacolo, curato da Leydi e dal regista Roberto Crivelli, dal titolo Bella Ciao; e naturalmente fu scandalo. Era stato inserito infatti un canto popolare della Prima guerra mondiale: O Gorizia, tu sei maledetta con l’aggiunta di una strofa antimilitarista che provocò polemiche e sollevò nel pubblico l’ira di alcuni militari che intonarono Faccetta nera; dall’altra parte ci fu chi cominciò a cantare Bandiera rossa. Lo spettacolo fu dunque accusato di vilipendio delle forze armate; erano altri tempi, ma chissà se oggi non potrebbe accadere…

Con il Canzoniere rimase negli anni una bella collaborazione che volle dire percorrere l’Italia in lungo e in largo, concerti, dischi, in particolare con esponenti della cosiddetta “canzone politica” fra cui Ivan Della Mea, Gualtiero Bertelli, Paolo Pietrangeli (incisero Contessa a due voci), il Duo di Piàdena, i tenores sardi. Comunque da allora la carriera fortunata di Giovanna fu un susseguirsi di esperienze, viaggi, ricerche di canti popolari, composizioni, docenze, pubblicazione di album e di libri; insomma una vita piena, ricca, attiva, in cui si inserì la nascita di un figlio e di una figlia, impegnata sempre nel valorizzare il nostro patrimonio musicale, anche di regioni a lei distanti come la Sardegna, la Puglia, l’Abruzzo, al punto da diventare una esponente di spicco dell’Istituto Ernesto De Martino rivolto allo studio antropologico e al recupero delle tradizioni. Necessariamente il suo percorso umano e professionale si intrecciò con quello delle cantautrici e musicologhe di allora, come Giovanna Daffini (1914-1969), Rosa Balistreri (1927-1990), Maria Carta (1934-1994), Caterina Bueno (1943-2007), che, come lei, pur partendo da formazione e ambienti diversi, andavano alla ricerca delle radici e non si stancavano di divulgare le loro scoperte e le loro conoscenze. Essenziale fu pure la partecipazione allo spettacolo Ci ragiono e canto (1965) in cui fu l’assistente musicale di Dario Fo, spettacolo che fece epoca e che fece nascere nuove occasioni di eventi pubblici, come l’esibizione in sue ballate con l’accompagnamento della sola chitarra.
Fra il 1969 e il 1971 portò avanti una proficua attività di indagine nel Salento dove trovò persone di una umanità straordinaria; lo racconta in un interessante articolo sul Venerdì di Repubblica (24-5-24) Giandomenico Curi che riferisce quanto quell’esperienza fu significativa per la eclettica musicista, convinta di aver individuato una serie di preziosi materiali, fra cui i canti “superbi” Fimmini fimmini e Lu povero Antonuccio, da riproporre negli anni successivi nei concerti e nella didattica. Già nel 1972 li portò in tournée con Fare musica e per questo, a grande distanza di tempo, nel 2019 Curi decise di ritornare con lei in quella terra per girare il documentario A sud della musica – La voce libera di Giovanna Marini, occasione per riprendere il contatto con la gente calorosa e ospitale e con musicisti di valore, come i maestri del canto griko Roberto ed Emanuele Licci.

«Il viaggio fu un’esperienza unica […] ricca di scoperte e momenti esaltanti, ma anche faticosa e divertente. Perché a Giovanna piaceva ridere e raccontare (a volte con spericolati arricchimenti). Lei diceva spesso che in Salento era andata a cercare i suoni e aveva trovato le persone. Perché un suono non è solo vibrazione, ma anche un fatto tremendamente politico». «Marini ― racconta nel film lo scrittore Brizio Montinaro, salentino cresciuto con una zia “chiangimorti” ― comincia a cantare come una lancia acutissima che sale al cielo, e un attimo dopo si alzano dieci lance che sono il coro. E il risultato è come un grande organo con tonalità acutissime e lei con i suoi svoli ti trapassa l’anima».
In Francia ebbe l’incarico di docente di etnomusicologia all’Università di Saint Denis a Parigi, che mantenne dal 1991 al 2000, ma intanto si era dedicata con impegno crescente alla Scuola Popolare di musica di Testaccio, a Roma, consapevole dell’importanza di portare la bellezza della musica ovunque e fra ogni genere di persone. Non va dimenticata la sua attività di compositrice e di divulgatrice di musica “colta” e della polifonia; da citare i raffinati brani Pavane e Vivaldi Spring, il suo commento sonoro alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1989), la collaborazione con Marco Paolini per uno spettacolo in memoria delle vittime del disastro di Ustica (2000) e quella con Enzo Alaimo per il progetto Villarosa, dedicato al ricordo della difficile emigrazione italiana in Belgio (2002). Quell’anno riscosse un grande successo l’album Il fischio del vapore, realizzato con Francesco De Gregori, che la fece conoscere al vasto pubblico. Giovanna Marini si è avvicinata in più occasioni anche alla letteratura, musicando La ballata del carcere di Reading e De Profundis di Oscar Wilde, liriche di Leopardi e Montale, Le ceneri di Gramsci di Pasolini, uomo e autore amatissimo che ha ricordato con una lunga serie di iniziative.
Nella sua instancabile attività non poteva mancare l’apporto al teatro e alla cinematografia, per cui Marini ha composto musiche di scena e colonne sonore: da segnalare il sodalizio con Francesco Maselli per quasi tutti i suoi film, da Lettera aperta a un giornale della sera a Il sospetto, e poi Nanni Loy con Café express (1980), Giancarlo Cobelli con Teresa Raquin, il documentario su Riace Un paese di Calabria (2016).
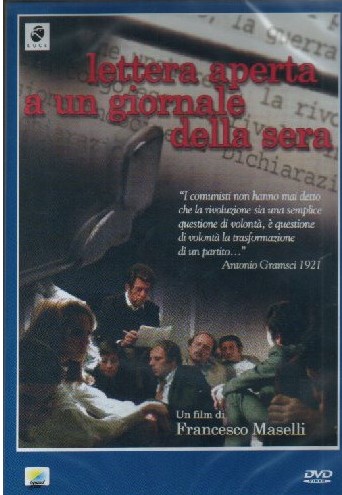
Impossibile citare i titoli dei suoi 33 album, i suoi cd, le tante partecipazioni a esperienze collettive, i documentari che l’hanno vista protagonista. Vari libri ne hanno raccontato viaggi e ricerche, talvolta è stata lei stessa a narrarsi (Italia quanto sei lunga, Una mattina mi son svegliata) o a dialogare con autori e autrici. Importanti e numerosi i riconoscimenti: commendatrice in Francia e in Italia, premio e targa Tenco, premio Nonino, svariati premi della critica e alla carriera in ogni parte d’Italia, premio Maria Carta e premio Concetta Barra, e così via.
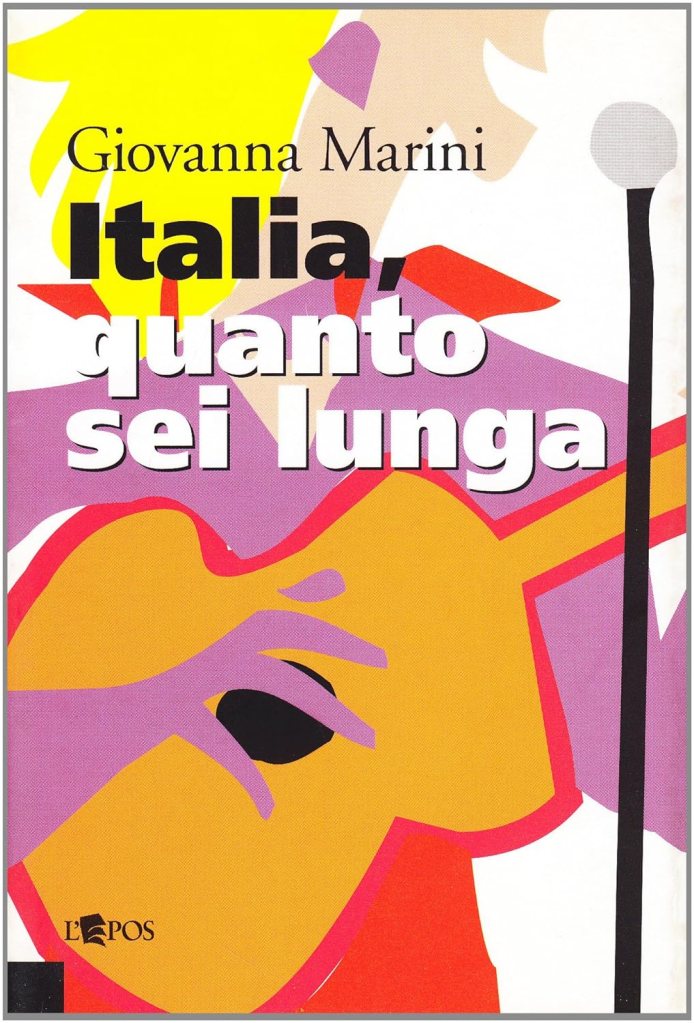
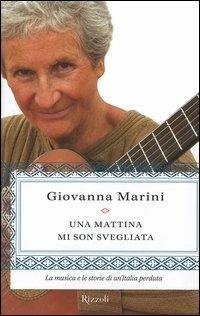
Fino alla fine della sua esistenza piena e generosa ha lavorato con entusiasmo sempre nuovo a progetti e collaborazioni: molto significativa nel 2021 la concertazione per uno spettacolo dedicato all’anniversario della nascita del Partito comunista italiano, ispirato alle memorie di Camilla Ravera, con l’esecuzione di cori e musiche a cura della Scuola Popolare di Testaccio. Conoscerla, vederla e ascoltarla oggi è possibile grazie a tanti documenti su You Tube che ce la restituiscono in pieno, mentre intona con la sua voce espressiva e decisa canti delle lavoratrici e di protesta, celebri ballate struggenti, canzoni del folklore regionale; c’è chi l’ha definita “la Joan Baez italiana”, ma, anche se l’intento vuole essere elogiativo, in realtà Giovanna Marini è stata molto di più e le etichette di folk-singer e di etnomusicologa le vanno strette: chiamiamola piuttosto musicista dalla forte impronta personale e compositrice di talento, donna e artista impagabile di cui stiamo già sentendo la mancanza.
In copertina: Giovanna Marini.
***
Articolo di Laura Candiani

Ex insegnante di Materie letterarie, dal 2012 collabora con Toponomastica femminile di cui è referente per la provincia di Pistoia. Scrive articoli e biografie, cura mostre e pubblicazioni, interviene in convegni. È fra le autrici del volume Le Mille. I primati delle donne. Ha scritto due guide al femminile dedicate al suo territorio: una sul capoluogo, l’altra intitolata La Valdinievole. Tracce, storie e percorsi di donne.


