Continuiamo il nostro percorso alla ricerca di libri che ci forniscano strumenti per interpretare il disagio del presente.
L’economia è cura. Una vita buona per tutti: dall’economia delle merci alla società dei bisogni e delle relazioni, di Ina Praetorius, di cui ho scritto anche per la nostra serie “Credito alle donne”, è un testo breve ma denso e profondo.
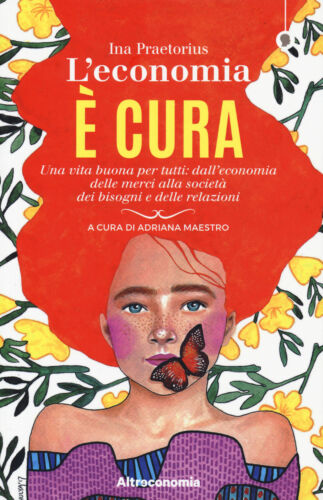
Ina Praetorius è una teologa economista svizzera, si definisce «una rompiscatole post patriarcale» e osa affrontare di petto quella che è considerata “una scienza cardine” nel nostro mondo, dominata per secoli dal pensiero maschile: l’economia politica. Non a caso in questa disciplina il Premio Nobel è stato conferito solo a tre donne: Elinor Ostrom nel 2009, che lo ha condiviso con un uomo, Esther Duflo, nel 2019, a cui è stato assegnato insieme al marito e a un altro economista e finalmente, nel 2023, Claudia Goldin che per la prima volta lo ha vinto da sola.
Per Praetorius è assolutamente necessario cambiare paradigma e affermare una volta per tutte che l’economia è cura.
Da una ricognizione dei manuali di economia politica in uso, l’economista svizzera scopre che per presentare questa disciplina si inizia sempre dalla sua etimologia. Il termine “economia” deriva da due parole greche, oíkos e nómos. Oíkos significa casa, nómos significa legge o insegnamento. Quindi l’oiko-nomia è la pratica e la teoria della gestione appropriata della casa, l’aggettivo politica che l’accompagna, e che alcuni/e volutamente dimenticano, indica la casa comune, la comunità. La definizione nei manuali è la seguente: «L’economia è la totalità di tutte le istituzioni e le azioni che servono alla soddisfazione pianificata dei bisogni». Tuttavia, basta girare pagina per scoprire che nei testi di economia politica il sistema presentato non è più descritto come una casa comune, ma come mercato. Al centro di questo mercato si trova l’homo oeconomicus, individuo razionale adulto che decide sempre liberamente quali merci produrre, dove e quando, con chi scambiarle e per quanto denaro. L’economia domestica e l’ambiente circostante rimangono fuori dal discorso: il centro dell’economia non è più la soddisfazione dei bisogni di tutti, ma «il libero gioco della domanda e dell’offerta». Come è potuto accadere?
Per capirlo bisogna ritornare all’antica Grecia, in cui era comunemente accettato che le società umane fossero composte da persone libere e da altre dipendenti. Il compito di quelle dipendenti era provvedere a tutte le necessità della vita e di generare la prole per l’oíkos. In questo modo, sottolinea Praetorius, queste persone hanno generato, oltre la vita, anche la libertà dei proprietari di schiavi, che potevano così dedicarsi ad attività “superiori”: la politica, la costruzione di teorie, la guerra.
In questo ordine sociale gerarchico si è formata la visione del mondo su cui ancora oggi poggia la scienza economica ortodossa: «il libero cittadino autoctono — ci ricorda Praetorius — possiede una casa privata in cui la moglie, casomai con il supporto del personale di servizio, badanti immigrate/i, asili nido, ragazze alla pari, nonne o bambinaie, garantisce, possibilmente in modo invisibile, che la cena sia pronta, il bambino o la bambina allattati, l’anziano e l’anziana curati, la casa ben sistemata e l’atmosfera armoniosa quando il cosiddetto capofamiglia (in tedesco: Ernährer, colui che nutre) torna a casa la sera da quell’attività chiamata “lavoro”». Questa impostazione dell’economia si è affermata dal XVIII secolo in poi con Adam Smith, secondo cui «economico» è sinonimo di «produttivo» nel senso di «scambiabile sul mercato, monetizzabile e portatore di guadagni».


Dagli scritti di Smith e degli altri economisti sono state ignorate tutte quelle attività, «tutte quelle mani, tutte quelle persone ― essenzialmente donne ― che, non lavorando nei vari settori produttivi non producono beni scambiabili sul mercato ― merci ― e perciò fonte di guadagno»; tutte le attività che hanno a che fare con la sfera della riproduzione e che sono propedeutiche, preparatorie, condizione necessaria per lo svolgersi delle attività produttive.
Una esclusione fondata su una concezione — che possiamo far risalire ad Aristotele — che divide il mondo, le attività e gli esseri umani in superiore e inferiore, alto e basso, spirito e corpo, maschio e femmina, padrone e schiavo, pubblico e privato, cultura e natura, scienza e fede, ragione e sentimento, teoria e pratica, pubblico e privato. Il posto delle donne secondo questa distinzione è nelle attività di cura, relegate alla sfera privata, inferiore, affine alla natura, che in questa visione dell’economia non ha alcuna importanza. In questo modo l’economia si allontana definitivamente da quello per cui è nata, secondo quanto apprendiamo dalle prime pagine dei manuali, cioè la soddisfazione dei bisogni umani. Non solo: si formalizza sempre più, si tecnicizza, si matematizza e diventa una “scienza triste”, per addetti e addette ai lavori.
Nel suo prezioso libretto Praetorius evidenzia una verità: «non sono le compagnie aeree, i banchieri, il calcio e gli accademici a tenere in piedi la vita umana e la convivenza nel vulnerabile ambiente della terra, ma i genitori, i nonni e le nonne, il personale di assistenza, le contadine, le infrastrutture pubbliche, i servizi di pulizia, di smaltimento dei rifiuti e di consegna». Ce lo ha insegnato la pandemia del 2020, da cui chi ci governa avrebbe potuto apprendere moltissimo e non lo ha fatto.

Secondo Praetorius è ora di scardinare la visione ortodossa dell’economia politica. La grande casa-mondo deve garantire a tutti coloro che vivono sotto il tetto comune ciò di cui hanno bisogno, per vivere senza danneggiare l’ambiente in cui la casa è inserita e da cui dipende. Economia ed ecologia sono connesse e occorre fare una rivoluzione silenziosa e diffusa. «Le rivoluzioni politiche sono introdotte da una sensazione sempre più forte, spesso avvertita solo da un settore della società, che le istituzioni esistenti hanno cessato di costituire una risposta adeguata ai problemi posti da una situazione che esse stesse hanno contribuito in parte a creare […] Lo stesso accade per le rivoluzioni scientifiche. Sia nello sviluppo sociale che in quello scientifico, la sensazione di cattivo funzionamento che può portare a una crisi è un requisito preliminare di ogni rivoluzione». Prendendo a prestito questa affermazione di Kuhn, l’economista svizzera ribadisce che il cambiamento di paradigma sarà realizzato da tutte e tutti coloro che vivono con crescente disagio la direzione intrapresa dal sistema economico, che ha emarginato ogni attività di cura, relegandola alla sfera extraeconomica: un altro errore frutto dello sguardo strabico del patriarcato.
La specificità e l’originalità dell’approccio di Praetorius stanno nel discostarsi dal pensiero delle economiste della cura, come Joan Tronto.

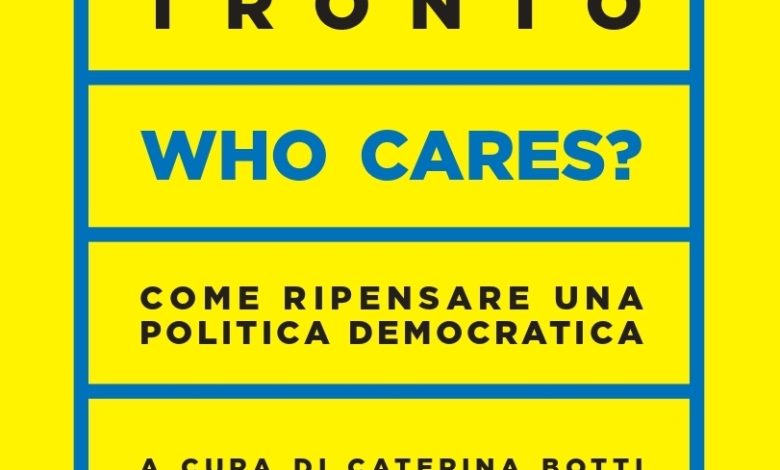
Queste ultime hanno proposto, e spesso ottenuto, che l’economia della cura diventasse una branca dei Dipartimenti universitari di economia. A Praetorius questo non basta, nonostante le ricerche di queste economiste abbiano grande importanza, soprattutto a proposito del rapporto tra cura e democrazia. Dobbiamo osare di più e sostenere che l’economia è cura.
(continua)
***
Articolo di Sara Marsico

Giornalista pubblicista, si definisce una escursionista con la “e” minuscola e una Camminatrice con la “C” maiuscola. Eterna apprendente, le piace divulgare quello che sa. Procuratrice legale per caso, docente per passione, da poco a riposo, scrive di donne, Costituzione, geopolitica e cammini.


