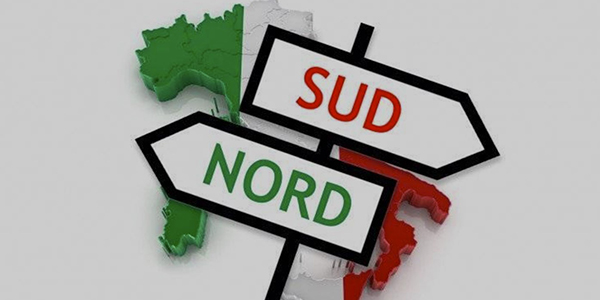In attesa della pubblicazione ufficiale dei risultati delle prove Invalsi 2024 (che, da indiscrezioni uscite in questi giorni, sappiamo essere perfettamente in linea con le precedenti, dunque scoraggianti), è interessante curiosare sul sito dedicato, che da quando è stato istituito (2018) non riserva mai una sorpresa, nemmeno per sbaglio. Il ritornello dei curatori delle pagine statistiche è sempre lo stesso: scuola del Nord batte scuola del Sud su tutta la linea. Cito da invalsi.it: «Le prove Invalsi 2023 hanno coinvolto oltre 1 milione di allievi della scuola primaria (classe seconda e classe quinta), circa 570.000 studenti della scuola secondaria di primo grado (classe terza) e più di 1 milione di studenti della scuola secondaria di secondo grado […]. Si riscontra ancora una differenza dei risultati tra scuole e tra classi, più accentuata nelle regioni meridionali, specie per quanto riguarda la Matematica e la prova di Listening. Ciò significa che la scuola nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi».
In seconda primaria, sulla prova di Italiano, la Calabria e la Sicilia risultano le regioni con le quote più basse di prestazione; in Matematica, dove circa il 64% (era il 70% nel 2022) degli e delle studenti italiane raggiunge almeno il livello base, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna registrano quote imbarazzanti. Le stesse tre regioni hanno peraltro il primato negativo sia sulle prove di Italiano che su quelle di Inglese delle classi quinte. Per fortuna, a livello nazionale, gli e le studenti che raggiungono risultati almeno adeguati, ossia in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali, sono la maggior parte: Italiano 62%; Matematica: 56%; Inglese-reading (A2): 80%; Inglese Listening (A2): 62% (+3 punti percentuali rispetto al 2022 e +11 punti rispetto al 2018, inizio della rilevazione). Riporta ancora il sito «I divari territoriali rimangono molto ampi. In alcune regioni del Mezzogiorno (in particolare Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) si riscontra il maggior numero di allievi (la metà circa) con livelli di risultato molto bassi o bassissimi. (…) Si confermano, in parte ampliate, forti evidenze di disuguaglianza di opportunità di apprendimento nelle regioni del Mezzogiorno, sia in termini di diversa capacità della scuola di attenuare l’effetto delle differenze socio-economico-culturali, sia in termini di differenze tra scuole e, soprattutto, tra classi».
Si passa poi all’analisi dei risultati della secondaria di primo e di secondo grado, dove «Le differenze tra l’Italia centro-settentrionale e quella meridionale si accentuano ulteriormente (…). Il divario tra Nord e Sud in Italiano raggiunge la quota di ben 23 punti percentuali; in Matematica di 31 punti percentuali». Un ingente divario di esiti tra il Centro-nord del Paese e il Mezzogiorno si evidenzia anche per quel che concerne la lingua Inglese, il che non sorprende, viste le difficoltà già riscontrate da ragazzi e ragazze nell’idioma materno. Si apre poi un piccolo spiraglio di speranza, subito però destinato a chiudersi: «In termini comparativi, il calo maggiore della dispersione scolastica implicita si registra in Calabria (-5 punti percentuali), in Puglia (-2,9 punti percentuali), Sardegna (-2,8 punti percentuali) e Sicilia (-2,4 punti percentuali). Tuttavia, le differenze assolute a livello territoriale rimangano molto elevate: Campania (19%), Sardegna (15,9 %), Sicilia (13,6%), Calabria (13 %) e Basilicata (10,6 %)». In Lombardia, per intenderci, la dispersione scolastica non arriva al 2%; in Veneto è dell’8%.
Con un quadro del genere, dico, se voi foste al Governo di questo Paese, che cosa fareste? Certo, iniziamo col dire che l’analisi Invalsi si ferma, in una prospettiva come sempre miope, strettamente cognitivista legata al secolo scorso, alle tre materie ritenute la base della formazione scolastica. Nulla, proprio nulla indaga circa i livelli di creatività, di competenza emotiva, di intelligenza sociale, né di quella morale, sportiva o musicale. Del resto, questo rappresenta anche il grande limite di tutti gli studi comparativi internazionali che riguardano i sistemi scolastici (i famosi Pisa, Ocse ecc.). Perché? Qual è la ragione per cui ci si focalizza esclusivamente sulla conoscenza scientifico/matematica o sulla comprensione linguistica? Perché la formazione della persona deve essere funzionale all’economia dei Paesi di appartenenza. A chi importa se cresciamo individui più simili a macchine, tutti centrati su competitività e performance, magari infelici, grigi e fragili di fronte al primo vero fallimento? Chi se ne frega se alunni e alunne ci chiedono sempre più insistentemente e disperatamente di aiutarli a capire chi sono, a scoprire sé stesse e le proprie qualità umane? L’importante è che ci facciano arrivare prima degli altri alla conquista dei pianeti, alle nuove frontiere dell’informatica, alla scoperta di cure efficaci per il cancro, vendibili sul mercato globale (non sia mai che i cervelli migliori si debbano spendere per la ricerca sulle patologie rare, per carità, che quelle non portano alcun profitto planetario. Per queste cose ci sono le Fondazioni o gli enti filantropici, che bastano e avanzano).
Non sappiamo, dunque, se, sulle aree non indagate, l’abisso tra Nord e Sud sia altrettanto significativo, ma resta il quadro mortificante sulle tre materie prese in esame. Cosa mai è stato fatto, dal 2018 a oggi, per recuperare l’evidente svantaggio del Sud? Sono state potenziate le strutture e i servizi per l’infanzia? No. Sono state messe in atto politiche di conciliazione famiglia/lavoro per i genitori? No. Sono stati erogati fondi per migliorare le strutture già esistenti e creare reti tra servizi per permettere interventi integrati su territori a rischio? No. Sono stati formati insegnanti speciali, super professionisti imbevuti di cultura psico-pedagogica, attrezzati umanamente e culturalmente, ricchi di strategie educative per contesti difficili e deprivati? Non mi risulta proprio. Ma i cambiamenti veri si fanno così. Si fanno con le persone (possibilmente quelle giuste al posto giusto) e con la cultura. Altrimenti è tutto un parlare, un gettare soldi a pioggia su progetti che oggi ci sono e domani no, senza alcuna possibilità di produrre alcun miglioramento stabile e duraturo.
Da qualche anno si sta pensando (e l’attuale governo guarda la faccenda con molto interesse) alla scuola a carattere differenziato regionale, con la possibilità da parte degli Istituti di gestire le proprie risorse in maniera autonoma. Alcune Regioni, come il Veneto, la Lombardia e l’Emilia-Romagna, già dal 2017 hanno presentato progetti di autonomia differenziata in materia di istruzione e formazione professionale. Questi progetti hanno l’intento dichiarato di migliorare la gestione delle scuole e la formazione professionale, assegnando agli Istituti la possibilità di organizzazione interna e lasciando in seno allo Stato solo la garanzia dei contenuti di insegnamento. I Sindacati hanno subito alzato le antenne, denunciando il rischio concreto che l’unità formativa nazionale venga compromessa ulteriormente e che i divari tra i territori si facciano ancora più netti. La materia è naturalmente complessa, ma proprio per questo si dovrebbe forse partire da uno sguardo meno istituzionale e più educativo. E magari confrontarsi con chi di educazione e formazione si occupa tutti i giorni. Cosa serve alla testa e al cuore dei nostri bambini e delle nostre ragazze? Quali condizioni rendono possibile quel rispecchiamento autentico nell’adulto, capace di far sbocciare i talenti, le passioni, il senso del Bello, del Giusto, del Buono nelle generazioni più giovani? Come la scuola, gli enti educativi, formativi, produttivi possono creare quelle alleanze strategiche capaci di rispondere trasversalmente ai bisogni e ai desideri delle nostre bambine e dei nostri adolescenti, oltre che della comunità? Come costruirla davvero questa comunità educante, in una società complessa e multi articolata, che è dai tempi di Platone che resta un orizzonte inarrivabile? E poi, questa idea meravigliosa del Bhutan di concretizzare la Felicità Interna Lorda, rendendola parametro imprescindibile per la scelta delle azioni governative, non potrebbe costituire un modello politico e culturale efficace anche per noi? Forse, prima di cercare soluzioni posticce, divisive, individualistiche, ideologiche sulla grande questione se esistano una o due Italie, bisognerebbe iniziare a farsi le domande giuste.
***
Articolo di Chiara Baldini

Classe 1978. Laureata in filosofia, specializzata in psicopedagogia, insegnante di sostegno. Consulente filosofica, da venti anni mi occupo di educazione.