Il 31 agosto 1973 moriva John Ford, il regista americano di origine irlandese nato nel 1894, padre del Western più tradizionale, che aveva iniziato all’epoca del muto. Ma fu nel 1939 che nacque il suo capolavoro, Ombre rosse, il film che rese il genere un “classico” intramontabile. È vero, c’erano i pellerossa cattivi, c’era l’assalto alla diligenza, c’erano la prostituta dal cuore d’oro e il medico ubriacone, e poi il provvidenziale arrivo della cavalleria, molti di quelli che sarebbero diventati elementi simbolici e irrinunciabili, alcuni dei quali oggi ritenuti politicamente scorretti, ma via via lui stesso rendeva le trame più problematiche, l’epopea si faceva più contraddittoria, lo stile diventava sempre più lirico. Pensiamo a Il grande sentiero, a L’uomo che uccise Liberty Valance, a Sentieri selvaggi. Ford non si limitò tuttavia ai Western, il cui volto emblematico fu John Wayne con il quale girò 21 film; nella sterminata filmografia vanno ricordati almeno Un uomo tranquillo e Furore, dal romanzo di Steinbeck. L’ultima sua opera, del 1966, fu una pellicola tutta al femminile: Seven Women, nota in Italia con il titolo di Missione in Manciuria, con l’indimenticabile Anne Bancroft nel bellissimo ruolo della generosa dottoressa Cartwright.

Gli anni Settanta appena iniziati stavano portando svolte epocali, a livello sociale, economico, politico, fra cui la fine ufficiale della Guerra del Vietnam con gli accordi di Parigi; Salvador Allende vince per la seconda volta le elezioni in Cile, ma l’11 settembre il golpe ne rovescia le sorti e ne causa la morte; vengono inaugurate le Torri gemelle di New York, intanto esplode lo scandalo Watergate che causerà le dimissioni di Nixon. La Grecia cessa di essere ufficialmente una monarchia (ma al potere sono i colonnelli) e Peron rientra trionfalmente in Argentina. In Medio Oriente si assiste alla guerra del Kippur, la Cee si allarga a 9 Paesi membri e l’Onu dichiara crimine internazionale il regime di apartheid del Sudafrica. Mentre siamo ancora in piena “guerra fredda” fra Usa e Urss, vari attentati si susseguono, in un generale clima di tensione: a Madrid l’Eta uccide il Presidente del governo Carrero Blanco; in Italia morti e feriti all’aeroporto di Fiumicino, in Versilia, a Milano (come dimenticare Roberto Franceschi?). Per contribuire alla pacificazione e alla collaborazione fra i partiti democratici il segretario del Pci Enrico Berlinguer il 28 settembre lancia la proposta del “compromesso storico” con la Dc.
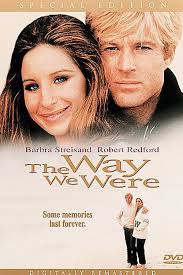
Nel 1973 la cinematografia statunitense fu particolarmente prolifica e fortunata e produsse una serie di pellicole rimaste nella storia, delle vere pietre miliari ciascuna nel proprio genere, e ce ne fu davvero per tutti i gusti. Se pensiamo al dramma romantico, la mente vola a Come eravamo per la regia di Sydney Pollack con la coppia Barbra Streisand e Robert Redford, e il sottofondo dell’omonima canzone: The Way We Were, vincitrice del Golden Globe e del doppio Oscar insieme all’intera colonna sonora. Storia struggente di una coppia fra anni Trenta e anni Sessanta, fra alti e bassi della loro relazione, venata di malinconia.
Redford era al culmine della carriera e un altro grande successo suggellò quel periodo fortunato: La stangata, per la regia di George Roy Hill, questa volta in una strepitosa coppia maschile con Paul Newman, due truffatori di strada che tentano il colpo della vita. Sette Oscar di cui uno alla avvincente colonna sonora che rielabora una serie di ragtime dei primi del XX secolo.

I due solo quattro anni prima erano stati i fuorilegge e rapinatori Butch Cassidy e Sundance Kid; indimenticabile quella volta la canzone di Bacharach Raindrops Keep Fallin’on My Head. Altra coppia, altro successo nel western “rivisitato” Pat Garret e Billy the Kid, diretto da Sam Peckinpah e interpretato da James Coburn e Kris Kristofferson, storia di due pistoleri realmente esistiti dal diverso destino e costretti dagli eventi a farsi una guerra spietata. La colonna sonora fu opera di Bob Dylan che ebbe un piccolo ruolo e lo stesso anno pubblicò l’album omonimo.
Ripensare a Serpico (regia di Sidney Lumet) vuol dire ricordare un attore senza se e senza ma: un Al Pacino bravissimo nel ruolo del poliziotto italo-americano Frank Serpico che operò a New York fra 1959 e 1972.

La sua superba interpretazione fu premiata con il Golden Globe e il David di Donatello. Anche Martin Scorsese girò un film ambientato a New York, ma in particolare nella Little Italy dove lui stesso è cresciuto: Mean Streets, con un grande Robert De Niro e un altrettanto grande Harvey Keitel; vicenda potente e drammatica di redenzione e di peccato, in una difficile realtà dominata da violenza, degrado e sopraffazione mafiosa.
Riguardo all’horror “estremo” (non quello di Shining o di Psycho, per capirci), basterà citare L’esorcista di William Friedkin (morto lo scorso 7 agosto), ritenuto dalla critica fra i capolavori, insieme a pochi altri, da Suspiria a Carrie, da Alien a Rosemary’s Baby; mi piace però ricordare che l’anno precedente il suo ottimo film d’azione Il braccio violento della legge (The French Connection) aveva ricevuto 5 Oscar fra cui quello alla migliore regia.
Pensando a un musical, dopo 50 anni, viene ancora in mente Jesus Christ Superstar di Norman Jewison, il prototipo moderno del genere, con cui successivamente ognuno (regista, produttore, sceneggiatore, compositore ― tutti al momento rigorosamente al maschile) ha dovuto per forza fare i conti. Sui palcoscenici del mondo è un classico senza tempo, opera dei due geni Rice e Webber, addirittura si continua a ingaggiare come protagonista il medesimo attore, Ted Neely, un Gesù attempato ma sempre credibile, almeno così lo intendono folle di fan che conoscono i bellissimi brani a memoria.
Ancora una commedia musicale, vincitrice del Golden Globe, con una colonna sonora fortunatissima, in cui si sorride e ci si commuove, all’insegna dell’autobiografismo, della nostalgia degli anni Sessanta, nell’ultima sera che quattro amici trascorrono insieme: ecco American Graffiti girato da George Lucas allora neppure trentenne.
Una risposta strana e provocatoria allo spiritualismo con ascendenze orientaleggianti fu La montagna sacra, opera del regista visionario Alejandro Jodorowsky, cileno naturalizzato francese, da inserire in quel filone che all’epoca aveva un notevole seguito e influenzava non poco la pubblica opinione, in America ma pure in Europa. Non per nulla era uscito l’anno prima Fratello sole, sorella luna di Zeffirelli; era il periodo degli hippie, celebrati a Woodstock (anche con il documentario omonimo, del 1970), le droghe più o meno leggere sembravano liberatorie e innocue, la beat generation e la cultura underground passavano l’Oceano con Corso, Ferlinghetti, Kerouac, Ginsberg grazie a quella meravigliosa intellettuale che fu Nanda Pivano, Bob Dylan e Joan Baez spopolavano con le loro ballate. C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones continuava a cantare Gianni Morandi, mentre si auspicava la fine della guerra del Vietnam.
Nel genere fantascientifico, anche se non passerà alla storia come un capolavoro, Il mondo dei robot risulta tuttavia interessante per più motivi, innanzitutto per la sceneggiatura e la regia di Michael Chricton (1942-2008), assai noto come prolifico romanziere dalla vena originale, autore di classici a loro volta portati sugli schermi da altri con successo strepitoso. Pensiamo a Jurassic Park, a Il mondo perduto, a Sol levante, a Congo. È stato pure il fortunato ideatore della serie televisiva ER-Medici in prima linea, amata in tutto il mondo. Oggi, per il tema centrale di cui si discute animatamente, il film è considerato un cult: si tratterebbe infatti della prima pellicola in cui si affronta l’ardua problematica della macchina che si ribella all’essere umano. Un altro motivo di curiosità è dato dunque dalla inesauribile passione dello scrittore per tutto quanto era nuovo, tecnologico, futuristico che ha indagato, studiato, inventato fino a crearne basi “scientifiche” anticipatrici di scoperte reali.
Non si può concludere la panoramica senza citare, proprio quell’anno, i tre Oscar e la serie infinita di premi internazionali a un film che ha fatto epoca, che continua ad appassionare, a far riflettere, ad avere imitazioni e varianti infinite. Stiamo parlando di The Godfather (IlPadrino), per la regia di Francis Ford Coppola, dal romanzo omonimo di Mario Puzo; la pellicola era ovviamente dell’anno precedente, visto che i riconoscimenti giungono quasi sempre quello successivo. A questa fecero seguito due sequel altrettanto memorabili: Il Padrino parte seconda (1974) e Il Padrino parte terza (1990). Intanto c’era un altro gioiello in lavorazione, che sarebbe uscito nel 1974: Chinatown, di quel genio controverso di Roman Polanski, felicemente novantenne. Ma questa è un’altra storia…
Al di qua dell’Atlantico cosa compariva nel frattempo sui grandi schermi, facendo concorrenza alle produzioni hollywoodiane?
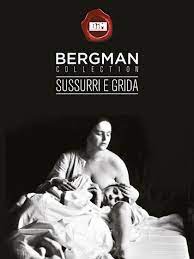
Il 1973 in Europa fu segnato sicuramente da due capolavori dello svedese Ingmar Bergman (1918-2007): Scene da un matrimonio e Sussurri e grida. Il primo a dire il vero nacque come sceneggiato televisivo in sei puntate trasmesso nel 1973 (in Italia nel 1978), poi ridotto a 167 minuti divisi in sei capitoli; in questa forma divenne un film presentato al pubblico l’anno successivo. Al centro il conflitto di una coppia in crisi, nel corso del tempo: lei è Marianne, avvocata, mentre Johan, di poco più anziano, è un docente universitario, genitori di due figlie. I due straordinari protagonisti sono, come spesso accade con il regista, Liv Ullman, sua compagna per vari anni e madre di sua figlia Linn, ed Erland Josephson. Nel 2021 è stato realizzato un remake, ma varie versioni sono state adattate per i palcoscenici; in Italia grande successo ha visto la messa in scena con Monica Guerritore e Gabriele Lavia, all’epoca coppia nella vita, diventata poi uno sceneggiato televisivo nel 1999. Sussurri e grida presentava al solito un cast classico per il maestro, con i suoi interpreti preferiti: da Ingrid Thulin a Liv Ullman, da Erland Josephson a Harriet Andersson; film drammatico pluripremiato che racconta una vicenda familiare estremamente dolorosa. Nonostante le difficoltà per produrlo che costrinsero attori, attrici e il regista stesso ad autofinanziarsi, fin da subito fu salutato come una delle opere più riuscite nella pur splendida carriera di Bergman. All’insegna del numero quattro, è la storia di tre sorelle di cui una morente e della donna di servizio che l’assiste amorevolmente, mentre scorrono nella mente di ognuna ricordi e pensieri, in un continuo flusso di coscienza. Ma altri tre protagonisti hanno un ruolo fondamentale: il tempo, il suono, il colore. Il primo è scandito dagli orologi, il secondo dalla sua frequente assenza, il terzo dal rosso, sfondo di molti fotogrammi e delle scenografie a simboleggiare la carnalità e il sangue.

Autentico gioiello della cinematografia francese fu Effetto notte, tredicesima pellicola di François Truffaut, il cui titolo originale (La nuit américaine) forse rende meglio il senso della trama. Si tratta infatti di quella tecnica che consente di far apparire notturne scene girate invece di giorno, e qui siamo proprio sul set mentre a Nizza un regista (lo stesso Truffaut) è al lavoro per realizzare Vi presento Pamela. Le vicende dal tono dolce-amaro fondono quanto avviene davanti alla macchina da presa con quanto vivono nella realtà gli ottimi interpreti, fra cui spicca l’attore “feticcio” Jean-Pierre Léaud, insieme a Valentina Cortese, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Aumont. Un inno al cinema europeo (in antitesi a quello hollywoodiano), un raffinato atto d’amore, una metafora della vita: i giudizi della critica furono unanimemente entusiasti e arrivò una pioggia di premi, fra cui l’Oscar al miglior film straniero.
La produzione italiana vide ai vertici due opere quanto mai distanti fra loro, grandi ognuna a suo modo: La grande abbuffata e Amarcord.

Fellini trovò la sua vena più sincera ed efficace nel riproporre, sul filo della memoria e della nostalgia, l’ambiente caldo e accogliente della sua giovinezza: Rimini negli anni Trenta con la sua variegata umanità, i personaggi più vivi ed emblematici. Anche il titolo fu geniale: quella trasposizione dialettale della semplice frase “io mi ricordo” offriva un rimando che divenne presto proverbiale. Non dimentichiamo l’influenza di Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore straordinario, che si divertiva a dare un’altra interpretazione al titolo, facendo riferimento all’ordinazione al bar di un noto amaro. Tante le scene che vengono alla mente, tanti i momenti struggenti: i sogni a occhi aperti del giovane Titta e dei suoi coetanei, l’arrivo del transatlantico Rex, lo zio matto sull’albero, la provocante Gradisca, il passaggio della Mille miglia. L’opera ottenne l’Oscar come miglior film straniero nel 1975, due David di Donatello, quattro Nastri d’argento, il Globo d’oro e tanti riconoscimenti internazionali.

Marco Ferreri (1928-97) è stato un personaggio controverso, amato e detestato dalla critica e dal pubblico per le sue pellicole provocatorie; pensiamo alla storia amara e tragica di La donna scimmia, a Dillinger è morto, L’udienza, La cagna, L’ape regina, Ciao maschio… Ogni volta era capace di stupire senza essere costretto in un genere o in un filone, lavorando in totale libertà, a costo di rimanere ai margini, e considerando centrali i ruoli femminili. La trama di La grande abbuffata è davvero crudele: una satira senza salvezza della società dei consumi, condannata ad autoestinguersi, in cui quattro amici decidono di mangiare fino a morirne, assistiti da una figura di donna materna e dalle forme generose che li aiuta e li assiste amorevole fino alla fine. Il cast era stellare, per quel momento: Mastroianni, Tognazzi, Noiret, Piccoli e la dolce Andrea Ferréol. Fischiato a Cannes e pesantemente censurato, oggi per la vena grottesca e la forza eversiva lo si avvicina ad altre pellicole “estreme” come Salò (1975) di Pasolini e Ultimo tango a Parigi di Bertolucci, uscito solo l’anno precedente.
Peccato non poter inserire in questa carrellata due bellissimi film girati da Paolo e Vittorio Taviani! San Michele aveva un gallo è infatti del 1972, Allonsanfan del 1974, a cavallo del fatidico 1973, ma vale la pena cercarli e rivederli per le loro intrinseche qualità espressive e le tematiche profondamente radicate nella nostra storia risorgimentale. Due geni mai troppo celebrati, questi due toscani dall’animo gentile e dalla inesauribile capacità creatrice.
***
Articolo di Laura Candiani

Ex insegnante di Materie letterarie, dal 2012 collabora con Toponomastica femminile di cui è referente per la provincia di Pistoia. Scrive articoli e biografie, cura mostre e pubblicazioni, interviene in convegni. È fra le autrici del volume Le Mille. I primati delle donne. Ha scritto due guide al femminile dedicate al suo territorio: una sul capoluogo, l’altra intitolata La Valdinievole. Tracce, storie e percorsi di donne.


