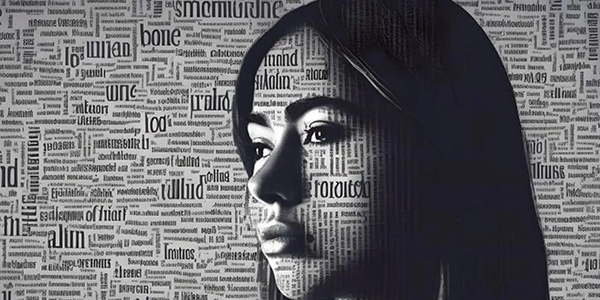È da qualche tempo che un pensiero mi rimbalza nella testa e finalmente è giunto il momento di dargli forma, di vestirlo di parole e vedere l’effetto che fa. Questo scritto è il tentativo di emanciparlo dalle mie cellule grigie e di dargli una vita autonoma, nella speranza che possa contribuire, seppur in modo limitato, alla discussione sui femminicidi e la violenza contro le donne. Ma partiamo un po’ da lontano.
Ogni giorno veniamo in contatto con parole nuove (i neologismi), talvolta importate da altre lingue, talvolta create con materiale morfologico italiano. È una caratteristica normale per una lingua, che si rinnova per adattarsi sempre meglio alle esigenze comunicative ed espressive delle comunità di parlanti. A volte questi neologismi durano il tempo di un’estate, altre volte si diffondono solo in un preciso gruppo di persone, per esempio giovani. Trovare esempi di parole nuove è facile e banale: ci sono quelle che servono per denotare tutti quei nuovi strumenti tecnologici entrati nelle nostre vite con la rivoluzione digitale e ci sono quelle che sono entrate nel nostro vocabolario attraverso la musica, i social media, la televisione e il cinema. Spesso esiste un’alternativa italiana valida, ma ciò non impedisce a chi parla di usare delle alternative “moderne”. In fondo, ogni neologismo riflette il tempo in cui viviamo. Oggi sono di uso comune parole inglesi (adattate o meno) che esprimono un concetto o una situazione (think thank, turnover, fake news, impeachment), una professione (manager, sales manager), un oggetto (mouse, computer, smart phone, cash), un comportamento (snitchare). Per questa ultima categoria si può pensare anche ad esempio a ghostare, a decluttering (fare ordine, eliminare il superfluo e riorganizzare gli ambienti della casa per renderla maggiormente accogliente) e anche a mobbing e stalking.
Questi due neologismi, che indicano dei reati sanzionabili e condannabili per legge, sono entrati nel linguaggio quotidiano verso la fine degli anni Novanta. Mobbing è considerato un neologismo di tipo semantico in quanto la parola esisteva già prima ma limitatamente al linguaggio tecnico specialistico dell’etologia, come spiegato nell’articolo pubblicato sul sito dell’Accademia della Crusca. Stalker invece è un anglicismo che è iniziato a circolare nel 1999, come ricostruito da Matilde Paoli, anche se è solo a partire dal 2007 che il Gradit e lo Zingarelli lo inseriscono tra i lemmi. Chiaramente non è che prima dell’introduzione delle parole mobbing e stalking questi comportamenti non esistessero e non ci fosse il modo di esprimerli (per stalking, ad esempio, ci sono le varianti italiane molestie assillanti — in ambito medico-psichiatrico — e anche atti persecutori — in ambito giuridico), ma sembrerebbe che l’introduzione di questi neologismi abbia favorito una maggiore consapevolezza nei confronti di questi comportamenti: le varianti sinonimiche italiane sembrano infatti «rivelarsi meno efficaci a livello di italiano comune, di quanto lo sia la forma inglese (…). Di fronte all’alta resa funzionale del termine inglese, gli equivalenti italiani usati in giurisprudenza e in psichiatria non mostrano la stessa immediatezza e non rispondono alle esigenze dello stile giornalistico». (Matilde Paoli, 2013, https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/in-inglese-stalking-in-italiano/833).
Il caso di mobbing e stalking mostra bene come la lingua sia costantemente alla ricerca di lessemi che riescano a esprimere efficacemente la realtà. E non necessariamente attingendo solo (e senza adattamenti) dalla lingua inglese. Pensiamo a femminicidio, di cui molto si è parlato alla fine dello scorso anno perché è stata dichiarata parola del 2023 dall’Accademia della Crusca. La storia di questo vocabolo inizia attorno agli anni Duemila, nel 2001 per la precisione: «Fino a quell’anno, l’unica parola esistente col significato di ‘uccisione di una donna’ era uxoricidio (…). Non avevamo una parola che alludesse all’uccisione della donna proprio in quanto donna (…). Nella lingua inglese invece, dal 1801 esisteva la parola femicide. E a questa prima parola se ne accostò, a partire dal 1992, un’altra che è feminicide», coniata dalla criminologa Diana Russell.
Inizialmente femminicidio era un termine con il quale si indicavano «tutte le forme di violenza contro la donna in quanto donna, praticate attraverso diverse condotte misogine (maltrattamenti, abusi sessuali, violenza fisica o psicologica), che possono culminare nell’omicidio» (cfr. Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_(Lessico-del-XXI-Secolo)/), per poi passare a indicare unicamente l’«uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale» (cfr. Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario/femminicidio_(Neologismi)/).
Non starò qui ad approfondire le motivazioni che hanno portato ad adottare questo neologismo, né mi metterò a ribadire la necessità di averlo inserito nel nostro repertorio linguistico perché già altri, prima di me, ne hanno scritto in modo chiaro, lucido e convincente. L’unica cosa che mi preme qui sottolineare è che nel corso degli anni il significato di femminicidio si è ristretto e ora non esprime più “tutte le forme di violenza contro la donna in quanto donna” (omicidio compreso) ma unicamente il culmine di queste forme di violenza: la morte. E qui torniamo al pensiero che mi circola per la testa da un po’: la lingua italiana accoglie o forma ogni anno parole nuove e nessuno se ne stupisce, è normale. E allora, perché non creare un neologismo per esprimere la parte di definizione non più riconducibile a femminicidio? Potremmo utilizzare questo nuovo termine per indicare, in modo sintetico, l’intero spettro di violenze, dalle aggressioni fisiche alle molestie psicologiche, dagli atti persecutori alle minacce, ai ricatti e alla manipolazione di cui sono vittime, purtroppo, molte donne e che a volte, ma non sempre, culminano nell’uccisione di una donna.
Immagino le obiezioni: perché? Non è ridondante? Forse sì, ma in fondo, come dimostrano mobbing e stalking, quando c’è un lessema specifico per indicare un comportamento, questo diventa maggiormente concreto, non è più generico. L’uso di una parola distinta e sintetica permetterebbe in questo caso di esprimere un disagio anche quando il problema è privato e confinato all’interno della coppia e non si è ancora manifestato nella sua più tragica forma.
A lungo mi sono interrogata su quale potesse essere questo ipotetico neologismo da inserire nel nostro vocabolario e, sinceramente, non sono arrivata a una conclusione che mi soddisfi. Mi sono venute in mente parole “macedonia” come femmi(ni)lenza (femmina e violenza) e femmi(ni)lestia (femmina e molestia). Ho poi pensato di ricorrere ai suffissi, ma anche in questo caso non ho trovato una soluzione davvero efficace. Malgrado la mia creatività linguistica non sia riuscita a trovare una soluzione soddisfacente, non ho abbandonato l’idea di trovare un termine che esprima e descriva in modo sintetico la situazione di sofferenza, violenza, difficoltà vissuta da molte donne a causa di mariti, compagni, fidanzati, spasimanti.
La lingua muta, cambia e si adatta alla realtà: e allora usiamo gli strumenti linguistici che abbiamo per aiutare le donne. Una parola non cambierà di certo la mentalità delle persone, non romperà le dinamiche distorte, non restituirà serenità e felicità a chi l’ha perduta a causa di una relazione “tossica”, e soprattutto non riporterà in vita nessuna. Per evitare altre tragedie occorre sicuramente un impegno costante e concreto a livello sociale, culturale e politico per promuovere la parità di genere e l’educazione al rispetto di sé e altrui. Tuttavia, anche se il potere di una singola parola è chiaramente limitato e marginale, la sua esistenza potrebbe aiutare a prendere maggiore coscienza di un problema, come è successo per femminicidio.
Dunque, che ne dite, la troviamo insieme questa parola?
***
Articolo di Lorenza Pescia De Lellis

Nata e cresciuta nel Canton Ticino, sono stata assistente al Romanisches Seminar di Zurigo e ho collaborato all’edizione degli Scritti linguistici di Carlo Salvioni. Attualmente vivo negli Stati Uniti e sono visiting scholar all’Institute for Advanced Study di Princeton. Tra i miei interessi di ricerca ci sono il linguaggio di genere, il multilinguismo e la politica linguistica, l’analisi del discorso, la storia della linguistica.