La compositrice anglo-americana Rebecca Clarke, rinomata a livello internazionale come virtuosa della viola, è stata anche una delle prime suonatrici orchestrali professioniste ed è considerata la compositrice britannica più illustre della generazione tra le due guerre, classificata da Gramophone Classical Music Awards come «una delle migliori del suo tempo».
Nata il 27 agosto 1886 nel borgo londinese di Harrow, nel Regno Unito, da Joseph Thacher Clarke, un americano, e da Agnes Paulina Helferich, tedesca, la sua è stata un’infanzia angustiata da un padre violento. Iniziò a suonare il violino a otto anni, dopo aver assistito alle lezioni che venivano impartite al fratello, Hans Thacher, di quindici mesi più piccolo di lei. Suo padre aveva un rigoroso senso della morale vittoriana ed era molto severo con la figlia, ma, avendo notato una sua precoce propensione per la musica ed essendo lui stesso interessato a questa disciplina, le consentì di entrare alla Royal Academy of Music nel 1903 per studiare violino.

Nel 1905 Rebecca abbandonò l’Accademia dopo aver rifiutato una proposta di matrimonio fattale dal suo insegnante di armonia, Percy Hilder Miles, che in seguito le lasciò nel testamento il proprio prezioso violino Stradivari. Dopo un breve periodo a casa, si iscrisse al Royal College of Music e fu una delle prime ragazze studenti di composizione di sir Charles Villiers Stanford. Su sua sollecitazione, spostò l’attenzione dal violino alla viola, studiando con Lionel Tertis, considerato da alcuni critici il più grande violista dell’epoca. Dovette lasciare il College nel 1910, quando il padre le tagliò i fondi, e si mantenne suonando la viola.
È stata una delle prime musiciste orchestrali professioniste dal momento in cui fu selezionata da sir Henry Wood per la Queen’s Hall Orchestra nel 1912.


Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, Clarke era negli Stati Uniti, dove si era trasferita per continuare la sua carriera artistica, e rimase bloccata non avendo ottenuto il visto per tornare in Gran Bretagna. Spesso ha composto sotto pseudonimi maschili, poiché l’idea che una donna potesse scrivere opere così complesse era socialmente inconcepibile.
Un breve duetto per viola e pianoforte, intitolato Morpheus, noto con lo pseudonimo di Anthony Trent, fu presentato in anteprima al suo recital congiunto del 1918 con la violoncellista May Mukle. L’anno successivo si classificò seconda in un concorso di composizione al Berkshire Festival con una Sonata per viola, questa volta firmata da lei stessa.

Il brano, sui settantadue presentati, si guadagnò grande considerazione, ottenendo successo di pubblico e il riconoscimento ufficiale di compositrice, ma la pubblicazione a stampa avverrà solo nel 1921 negli Stati Uniti, certamente più aperti alla musica al femminile dell’Inghilterra. La sua Sonata si compone di tre movimenti: impetuoso, vivace, adagio; il finale si libera in forma brillante, concludendosi con la stessa forza che caratterizza l’inizio, con il pianoforte che incalza l’ossessiva tessitura della viola.
Nel 1924 Rebecca intraprese la carriera di solista e di appartenente a un ensemble a Londra, dopo aver completato per la prima volta un tour mondiale nel biennio 1922-23. Si è pure esibita in diverse registrazioni negli anni Venti e Trenta e ha partecipato a trasmissioni musicali della Bbc. La sua produzione successiva fu sporadica, in quanto cominciò a soffrire di una forma cronica di depressione, dovuta anche allo sconforto per lo scarso apprezzamento che riceveva per il suo lavoro.

Casualmente in una strada di Manhattan incontrò James Friskin, un compositore e pianista da concerto che era stato suo compagno al Royal College of Music, e i due si sposarono nel 1944, quando entrambi avevano circa cinquant’anni. Dopo il matrimonio, Rebecca smise di esibirsi e di comporre, nonostante l’incoraggiamento del marito, anche se ha continuato a lavorare sugli arrangiamenti fino a poco prima della morte. Vendette lo Stradivari che le era stato lasciato in eredità e istituì il premio May Mukle per violoncellisti alla Royal Academy, premio che viene ancora oggi assegnato ogni anno.

Dopo la morte del marito nel 1967, Clarke iniziò a scrivere un libro di memorie, completato nel 1973, ma mai pubblicato. Vi descrive i suoi primi anni di vita, segnati dalle frequenti percosse da parte del padre e da relazioni familiari tese che hanno influenzato negativamente la sua esistenza.
Morì nella propria casa di New York all’età di 93 anni, il 13 ottobre 1979. Le sue opere ricordano quelle di altri compositori inglesi dell’inizio del XX secolo, conformi allo stile in voga. Clarke conosceva molti importanti musicisti dell’epoca, tra cui Bloch e Ravel, ai quali il suo lavoro è stato paragonato, anche Debussy è spesso citato tra i suoi ispiratori. C’è una chiarezza di trama, densa e ritmicamente complessa, in gran parte della sua musica, così come un’inclinazione impressionista e una natura emotivamente intensa. Tra il 1939 e il 1942, l’ultimo periodo prolifico verso la fine della carriera compositiva, il suo stile divenne più chiaro e contrappuntistico, con tratti distintivi del neoclassicismo.
Gran parte della sua produzione è stata scritta per gli ensemble da camera di sole donne in cui ha suonato, tra cui il Norah Clench Quartet, l’English Ensemble e Le d’Aranyi Sisters. Le sue composizioni in totale comprendono cinquantadue brani per voce solista accompagnati da pianoforte e/o violino, undici opere corali, ventuno brani da camera. La Sonata per viola (1919), Morpheus (1917-18), Rapsodia per violoncello e pianoforte (1923), Midsummer Moon, Dumka (1941) per violino, viola e pianoforte recentemente pubblicata, Passacaglia su una antica melodia inglese per viola (o violoncello) e pianoforte (1940-41), Preludio, Allegro e Pastorale (1941), brano influenzato dal neoclassicismo, scritto per clarinetto e viola, sono le sue opere più note. Oltre alla musica da camera per archi, Clarke ha scritto molte canzoni, di natura più leggera. The Seal Man per voce solista e pianoforte (1922), con parole di John Masefield, e Tiger, Tiger per voce e pianoforte (1929-33), con parole di William Blake, sono le più conosciute ed eseguite. Il suo lavoro è stato dimenticato per un lungo periodo di tempo, ma ha riconquistato interesse nel 1976 in seguito a una trasmissione radiofonica che celebrava il suo novantesimo compleanno. Oltre la metà della sua produzione rimane inedita e in possesso personale degli eredi, e molti pezzi sono stati pubblicati solo di recente.
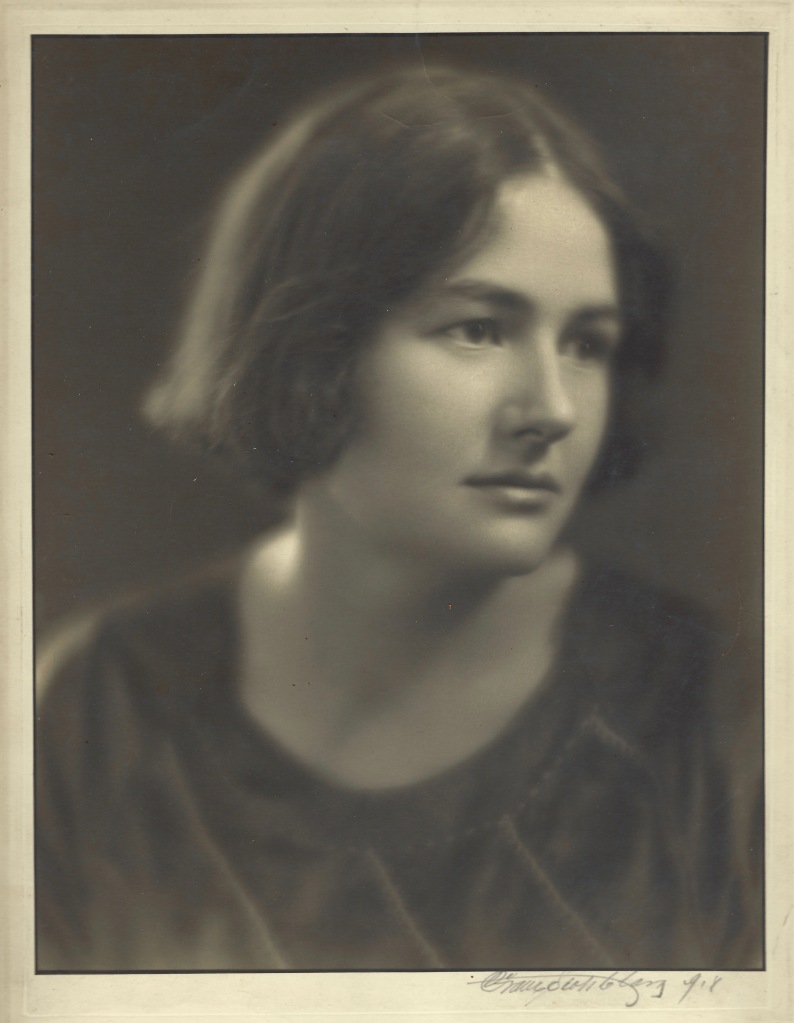

La Rebecca Clarke Society è stata fondata nel 2000 per promuovere lo studio e l’esecuzione della sua musica dalle musicologhe Liane Curtis e Jessie Ann Owens, e ha sede presso il Women’s Studies Research Center alla Brandeis University. La Società ha reso disponibili composizioni inedite della musicista, pubblicando oltre venticinque opere precedentemente sconosciute e anche A Rebecca Clarke Reader. L’accoglienza moderna del lavoro di Clarke è stata generalmente positiva. La sua Sonata per viola in una recensione del 1981 è stata definita un «pezzo premuroso e ben costruito»; una recensione del 1985 ne notava «l’intensità emotiva e l’uso di colori dai toni scuri». Andrew Achenbach ha definito Morpheus «sorprendente» e «languido». Laurence Vittes ha notato che la sua Ninna nanna è «estremamente dolce e tenera». Nel 2017 Bbc Radio 3 ha dedicato cinque ore alla sua musica come compositrice della settimana.
Qui la traduzione in inglese, francese e spagnolo.
***
Articolo di Livia Capasso

Laureata in Lettere moderne a indirizzo storico-artistico, ha insegnato Storia dell’arte nei licei fino al pensionamento. Accostatasi a tematiche femministe, è tra le fondatrici dell’associazione Toponomastica femminile. Ha scritto Le maestre dell’arte, pubblicato da Nemapress nel 2021, una storia dell’arte tutta al femminile, dalla preistoria ai nostri giorni.


