Isabella Guanzini è filosofa e teologa, docente universitaria prima alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, poi ricercatrice all’Università di Vienna, ora ordinaria di Teologia fondamentale all’Università di Linz.
Qual è stato il tuo percorso di studio e lavoro e quale motivazione ti ha portato a intraprenderlo?
Ho deciso di studiare filosofia, a Milano, all’Università Cattolica: mi sono immersa, così, in quattro anni in studi filosofici piuttosto classici. Il mio primo incontro con la teologia è avvenuto lì: all’Università Cattolica occorre sostenere tre esami di teologia obbligatori; è stato un evento destinale, totalmente a caso mi sono scontrata con un libro che ha avuto per me il senso di un incontro inatteso e perturbante, Il timore di Dio di Pierangelo Sequeri, che dopo molti anni è divenuto per me ‘il’ maestro. Inconsciamente ero già indirizzato verso la teologia: quella di Sequeri è stata lettura, oltre che casuale, molto sovversiva, che nulla aveva a che fare con l’immagine di discorso cristiano che avevo fino ad allora incontrato e sviluppato.
Dopo la laurea ho iniziato subito a lavorare in Rcs libri: mi sono occupata di saggistica, ho letto tantissimi libri storici e filosofici e corretto bozze, fino alla fatidica decisione di fare il concorso per l’insegnamento. Ero attraversata da sogni di gloria, non volevo fare il lavoro di mia madre, non volevo ripetere il modello materno. Feci il concorso nel nome della madre, con un senso di conflitto interno… ma la voce della madre era forte, vinsi il concorso, ottenni una cattedra piena al liceo. Dal niente ebbi 18 ore settimanali di filosofia, che da neofita affrontai con passione.
Nell’anno di grazia 2000, dunque, sette anni dopo la laurea, iniziai a insegnare e a studiare teologia, un desiderio sempre rimasto vivo in me. Non conoscevo nessuno che studiasse teologia: in Italia, frequentavano la facoltà teologica sacerdoti, studiosi o persone strane, borderline… I miei genitori si opposero a questa scelta, non vollero pagarmi le tasse universitarie; mi incoraggiò, invece, il mio fidanzato di allora, anticlericale e comunista: «Se devo avere una fidanzata cattolica – disse – che almeno studi». Decisi di rivolgermi a un industriale della mia città e andai dal vescovo per chiedere una lettera di accompagnamento: e il vescovo decise lui di finanziarmi gli studi, mi fece avere una borsa di studio. Per dieci anni ho studiato teologia, nel frattempo insegnavo, iniziai a fare corsi, presi una pausa dall’insegnamento quando nel 2009 vinsi il dottorato di ricerca in filosofia all’Università Cattolica. A scuola, poi, non sono più rientrata.
Studiare teologia era un desiderio che mi attraversava, che riconduco alla visione di un film tratto dall’autobiografia di Ingmar Bergman, Con le migliori intenzioni (il padre del regista era un teologo) e alla lettura di Timore e tremore di Kierkegaard, che pone al centro la domanda su Dio.

In particolare, perché il passaggio dall’Italia all’Austria? Quali difficoltà hai incontrato?
È stato un passaggio del tutto casuale, volevo trascorrere un periodo di studio all’estero, ero già in contatto con Julia Kristeva a Parigi. Studiavo ancora alla facoltà teologica, un professore di Vienna mi propose di andare, appunto, a Vienna. Fu un incontro casuale, questo docente e Sequeri mi traghettarono da Parigi a Vienna, con il piccolo dettaglio che non sapevo il tedesco. La lingua è stata una grande prova per me, dopo pochi mesi avrei tenuto un seminario in tedesco. Ho imparato la lingua scrivendo, lavoravo tutto il giorno, sono entrata nella lingua attraverso la scrittura, attraverso un tedesco molto eccentrico, quello di Heidegger e della teologia, un tedesco italianizzato, colto, antiquato, da docente in esilio che non abita la sua lingua.

La lingua vuol dire tutto: ho affrontato un processo di dis-identificazione, è stato un passaggio fondante per la mia biografia, e decisivo per il mio modo di fare filosofia e teologia. Un passaggio connotato da grande ansia, angoscia, disorientamento, ma necessario: ora sono in una situazione di esilio dalla mia lingua, ho perso le mie origini, sono senza radici… Non mi sono immersa completamente nella lingua dell’altro: mi piace scrivere in tedesco, riesco a dire le cose in modo unico, ma mantengo una grande distanza, non tengo ad avere una pronuncia perfetta. È come se io abitassi un’altra lingua, accetto di essere senza radici, ma non ne ho cercate altre. Dopo aver vissuto lo spaesamento nella lingua d’arrivo, non ho affrontato un processo di ri-radicamento. Ho un figlio per il quale la lingua materna non è la mia, anche se io con lui parlo in italiano, e lui mi risponde in italiano.

Due tra i tuoi libri più recenti (Tenerezza del 2017 e Filosofia della gioia del 2021) contengono parole che evocano gentilezza e cura, qualità che rimandano culturalmente al femminile, per quanto praticate anche da uomini (per esempio da Papa Francesco). Come sei arrivata ad approfondire questi temi?
Entrambi i temi esprimono una forma di protesta e di resistenza, quasi di rivolta, nei confronti di situazioni che mi sono trovata ad affrontare a livello socioculturale. Tenerezza guarda in particolare a due sintomi: la durezza di molte relazioni del presente, che irrigidiscono le vene e le arterie del circuito cittadino, e l’infinita stanchezza che attraversa il mondo del lavoro, della famiglia… Italo Calvino, nelle Lezioni americane, scrive di un lento processo di pietrificazione della società contemporanea, come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo di Medusa. Ecco, le pratiche della tenerezza sono proprio una forma politica di protesta nei confronti della pietrificazione. Riguardo alla stanchezza, invece, di cui hanno scritto Peter Handke e, in particolare, Byung-chul Han (che ha teorizzato il concetto di ‘società della stanchezza’, nella quale, esaltando la produttività come valore assoluto, siamo tutti carnefici e vittime di noi stessi), penso che un antidoto possa essere lo Shabbat, il grande dono della tradizione ebraica, che invita non solo a fare, a produrre, ma a darsi in tempo per dare senso, per riflettere.
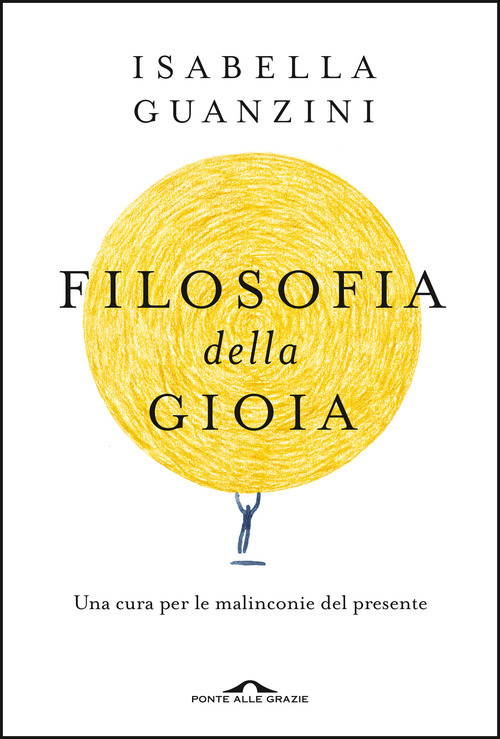
Filosofia della gioia, invece, è stato scritto nel tempo della pandemia, è un’altra forma di protesta, un concetto molto spinoziano, ripreso da Gilles Deleuze, una protesta nei confronti della tristezza della pandemia, una risposta all’accumulo di delusione e insicurezza, in un tempo di grandi trasformazioni. Sono due titoli emotivi ma rinviano a concetti critici e politici, che vogliono reagire e mettere in circolazione parole che non esistono, dare loro vita attraverso il linguaggio. È stato un atto di coraggio parlarne in ambito teologico, mi sono esposta molto.
Donna e teologa. Non sei la prima, ma come vivi questa condizione, in un ambiente che, per esempio in Italia, è ancora maschile?
Vivo questa condizione con un senso di gratitudine nei confronti delle donne che mi hanno preceduto: da circa cinquant’anni, vi sono donne teologhe, ma per lo più sono state scoperte molto recentemente. Il terreno, comunque, è dissodato: in Germania una teologa donna docente non è una figura anomala, in Italia sì. Esiste un coordinamento delle teologhe italiane, ma la teologia in Italia resta ancora molto maschile e clericale e alcuni temi restano sospetti: gender, femminismo, sacerdozio femminile… Chi si occupa ‘troppo’ di questi temi rischia di non ottenere nulla osta all’insegnamento. Ancora, in Italia ci sono convegni teologici in cui compaiono solo nomi maschili, questo sarebbe impossibile all’estero, lo stile teologico è molto affermativo, universalistico. La teologia femminile o femminista, invece, ha un accento più storico, contingente. Le donne teologhe, comunque, non sono più casi isolati.

Nella cultura patriarcale Dio è sempre declinato al maschile. Ma in Europa qualcosa si muove. Vuoi raccontarcelo?
Per rispondere a questa domanda occorre nominare le origini: Mary Daly nel 1973 ha pubblicato il libro Al di là di Dio padre, come reazione all’ideologia maschilista, rifiuto della distorsione dei rapporti umani, critica alla tradizione biblica ed ecclesiastica, sostenendo la necessità di uscire dalla tradizione del testo biblico attraverso il tentativo di utilizzare una lingua capace di superare il patriarcato, con il quale la Bibbia è evidentemente compromessa.
Rosemary Radford Ruether ha avuto invece una parabola più intra-teologica, negli anni Settanta ha iniziato a rileggere la Bibbia attraverso categorie più femministe, recuperando una tradizione profetica nella quale la Bibbia ha incorporato una critica al patriarcato. Questa corrente è ora più diffusa: la Bibbia è considerata uno spazio letterario, mitologico, narrativo, in cui Dio è anche donna, madre, nutrice, perché la lingua ebraica lo permette in alcuni casi. Quando si parla di Dio, infatti, in lingua ebraica, in alcuni passaggi non c’è il pronome maschile né quello femminile; questi passaggi, da alcuni teologi e teologhe sono tradotti utilizzando il pronome ‘lei’, per una questione di giustizia, per compensare secoli di traduzioni nelle quali si è utilizzato il pronome maschile. Si ricorre al linguaggio sessuato anche per i discepoli di Gesù: discepoli e discepole!
Un’altra attenzione, alla quale partecipano i maggiori esegeti tedeschi, è nei confronti degli ebrei, anche perché Gesù era ebreo. La questione del linguaggio è centrale, ha a che fare con la contaminazione, con il dialogo tra teologia e cultural studies: in Germania e in Austria la teologia è insegnata in facoltà pubbliche, in Italia no. Vi è dunque molta attenzione ai minimi necessari di correttezza del discorso rispetto a patriarcato, gender, e questi canoni valgono per tutti e tutte. Della concezione di Dio come padre e madre vi sono tracce antichissime, quale altro femminile che ha a che fare con il corpo della lingua e con la questione della generazione.

Quali progetti di studio e ricerca hai per il futuro?
I miei progetti riguardano sostanzialmente tre ambiti. Un libro su Pascal, La vita distratta; Pascal propone una analitica esistenziale attualissima, dimostra grande sensibilità per la condizione umana, ha coscienza dei limiti del sapere scientifico.
L’approfondimento, che conduco da qualche anno, del rapporto tra Bibbia e psicoanalisi, in collaborazione con la Società milanese di psicoanalisi. Fino a poco tempo fa, la psicoanalisi dalla teologia era considerata ‘il nemico’; io penso invece che soprattutto la prospettiva di Lacan possa dare grandi stimoli alla lettura della Bibbia, di Agostino e della tradizione mistica.
Lo studio del rapporto tra teologia ed estetica, tra opera d’arte e lavoro di simbolizzazione; la teologia cerca di simbolizzare l’in-simbolizzabile, e per questo deve operare non solo sotto il profilo razionalistico argomentativo, ma farsi anche teologia del sentire e degli affetti. In Germania, per esempio, lo studio delle emozioni e degli affetti nella Bibbia è molto presente.
Quali consigli daresti a una giovane che vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso?
Di restare fedele al proprio desiderio – e di questo posso essere testimone – di non rimuovere il desiderio di entrare in questo mondo ricchissimo, che offre strumenti di analisi per il presente: la filosofia laica, secolare, va infatti ritraducendo concetti biblico-cristiani in maniera sistematica, queste risorse non devono rimanere inerti. Occorre però scegliere luoghi adatti, perché molte facoltà sono rimaste nell’alveo della tradizione e invece occorre ridare vita a una storia. E di non aver paura di uscire dall’Italia…
In copertina: Isabella Guanzini (© midivertounmondo).
***
Articolo di Laura Coci

Fino a metà della vita è stata filologa e studiosa del romanzo del Seicento veneziano. Negli anni della lunga guerra balcanica, ha promosso azioni di sostegno alla società civile e di accoglienza di rifugiati e minori. Dopo aver insegnato letteratura italiana e storia nei licei, è ora presidente dell’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.


