Se non avete mai ascoltato l’intervento The danger of a single story (link: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?subtitle=en&language=it&lng=it&geo=it) dell’autrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie è il momento di farlo.

Il testo, letto in occasione della prima conferenza Ted della scrittrice (2009), è un monito universale per non cadere nella trappola dell’unica storia, la narrazione definita dal principio nkali (parola igbo traducibile come “essere più grande di un altro”, riflesso delle strutture di potere esistenti) che genera stereotipi e semplificazioni.

La prima volta che ho ascoltato le sue parole mi sono sentita terribilmente colpevole e stupida; ora, le cose si facevano nitide e non avevo scampo: ero caduta nella trappola e, mio malgrado, dovevo accettare il fatto di aver partecipato alla sua costruzione. Il principio nkali mi riguardava. Aver comprato libri di autori/autrici africane (poi rimasti a ingiallire, stretti fra le opere di Fallaci, Calvino, McGrath, ecc), ascoltato la loro musica, sognato di visitare il continente africano, persino il mio desiderio infantile di avere la pelle nera e i capelli ricci voluminosi e ampi a incorniciarmi il viso, non mi esoneravano dalla responsabilità.
Avevo accolto, e accettato senza pormi troppe domande, la narrazione mainstream offerta da quella parte del mondo da cui provengo che riduceva quella del globo che non conosco a una terra povera, da cui la gente desiderava scappare o dove gli individui restavano in paziente attesa dell’uomo bianco che li avrebbe salvati.
L’intervento di Chimamanda Ngozi Adichie, probabilmente sconosciuto ai più, non ha cambiato il mio Paese e quelli che, come lui, si sentono più grandi di un altro, ma ha cambiato me. E ora, quando leggo libri o ascolto notizie riguardanti ciò che non ho visto con i miei occhi o che non conosco direttamente, ho uno strumento in più per accettare o prendere le distanze da ciò che è scritto o detto, per mettere in discussione e comprendere che la narrazione manca, nella maggior parte dei casi, del punto di vista più importante: quello di chi è raccontato.
Scoprendo il mondo attraverso occhi non nostri, prestando attenzione a voci solitamente inascoltate, entriamo in contatto con realtà molto più complesse dalle riduzioni a cui le avevamo obbligate e diamo spazio a storie non più usate per espropriare e diffamare ma per riparare a quella dignità spezzata e ridare potere.
Un’efficace terapia d’urto contro il pericolo di un’unica storia potrebbe consistere nella lettura di quei testi prodotti dalle soggettività che si considerano altro da noi, opere in grado di enfatizzare le somiglianze piuttosto che le diversità, antidoti contro il razzismo (anche quello “positivo”) e le categorizzazioni semplicistiche.
Non vi stupirà quindi sapere che, attualmente, l’autrice di queste righe è in cura e il primo medicinale che si è auto-prescritta è la lettura di L’ibisco viola, opera d’esordio della già citata Chimamanda Ngozi Adiche che le valse l’Orange Prize e il Commonwealth Writers’ Prize.
Anche se viene definito dai più come un romanzo di formazione (che certamente è), mi piace definirlo un romanzo orale, in cui tutto ciò che si ricollega all’apparato preposto ha un significato più profondo in quanto strumento adottato per scandire tempi, differenze (di luoghi e di emozioni), situazioni (piacevoli o di violenza) e cambiamenti.
L’illustrazione presente sulla copertina del libro edito da Einaudi, che ritrae il volto di una donna con la bocca aperta, sembra corroborare l’idea della centralità dell’organo e di tutto quanto passa o si percepisce attraverso lo stesso.
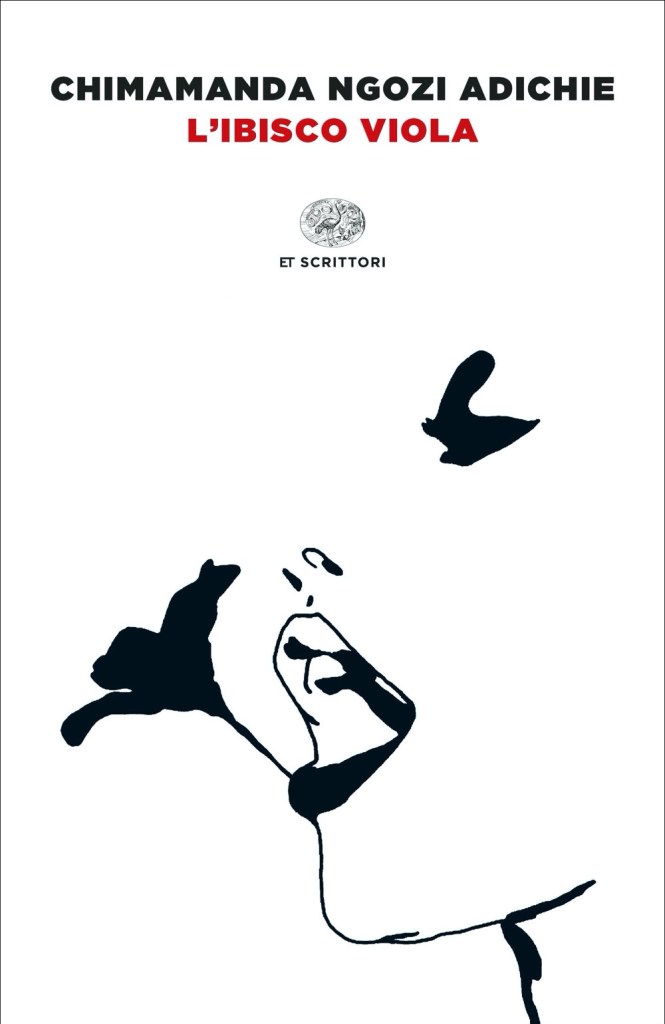
Kambili, la quindicenne protagonista, sente il proprio corpo attraverso la sua lingua che, a seconda della situazione, le sembra carta, fuoco o zucchero. La graduale presa di consapevolezza della ragazza, così come il suo passaggio dall’adolescenza all’età adulta, è marcato dall’atto del parlare: prima flebile e desueto e poi sempre meno trattenuto. Anche i pasti, nella loro diversità, segnano passaggi decisivi e contraddistinguono le due realtà in cui la protagonista e il fratello Jaja sono immersi.
Nella casa paterna, ritrovarsi insieme intorno a una tavola è spesso preludio o epilogo di maltrattamenti; da zia Ifeoma, dove vanno ad abitare i due adolescenti dopo un colpo di Stato, mangiare con i propri cari rappresenta invece un momento di condivisione e di libertà.
Non è un caso allora se il crollo con cui si apre il romanzo sia determinato dal rifiuto di Jaja di accogliere il corpo di Cristo nella sua bocca e se nella conclusione del racconto si ricorra ancora una volta alla cavità orale per segnare un ultimo e decisivo transito.
Ma la lingua, intesa ora come idioma, segna pure il passo da un ambiente autoritario, patriarcale e violento, in cui si tenta di fare astrazione delle proprie origini, a uno spazio femminile profondamente radicato nelle tradizioni del territorio. La dicotomia tra cancellazione e celebrazione si realizza anche attraverso il culto religioso. La più dura delle battaglie tra omologazione e resistenza si combatte proprio su questo campo.
Emblema dello scontro è la figura di Amaka, cugina di Kambili. Il suo rifiuto di acquisire un nome inglese, azione necessaria per la celebrazione della sua cresima, e l’acquerello da lei realizzato, sorta di Vergine con il Bambino in cui i personaggi ritratti hanno, in questo caso, la pelle scura, sono il simbolo del dissenso nei confronti dei «missionari bianchi […] che ci hanno portato il loro Dio, che aveva il loro stesso colore», le loro tradizioni e imposto la loro lingua, disabilitando l’igbo (idioma dell’omonimo gruppo etnico africano).
Le parole e le intenzioni di Amaka costituiscono un rimprovero manifesto contro un Occidente dispotico e contraddittorio che si concretizza nella corporeità del padre di Jaja e Kambili, Eugene, e nella sua devozione fanatica al cattolicesimo. Proprietario dell’unico giornale indipendente del Paese, modello di generosità e coraggio, l’omelora (“colui che lavora per la comunità”) Eugene personifica la violenza del colonizzatore, dell’uomo benestante, istruito e cattolico (da cui si discosta solo per il colore della pelle) che si erge a Dio e intende modellare gli altri (la propria famiglia) a sua immagine e somiglianza, non disdegnando l’uso della violenza.
Attraverso il suo personaggio, Adichie ci mostra un cristianesimo autocratico, lontano dal messaggio evangelico. Ma contro la sua figura, contro questa parte di mondo che classifica e ordina a suo piacimento, se ne erge un’altra, che fa meno scalpore, più silenziosa ma altrettanto potente, che sa sacrificarsi e ribellarsi; capace di restare per piantare nuovamente fiori di ibisco viola anche dopo che qualcuno li ha calpestati. Chimamanda Ngozi Adichie ci offre un antidoto contro l’ignoranza, sta a noi iniziare la terapia.
***
Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.


