Nel panorama intellettuale Donna Haraway risulta di difficile catalogazione: la sua formazione culturale le permette di far interagire la filosofia con la biologia; impossibile decidere quale tra le due abbia avuto un ruolo privilegiato nel suo pensiero: biologia e filosofia sono aree disciplinari da cui ricavare gli attrezzi del discorso. Le sue teorie sono eterodosse al punto da risultare aliene persino al post-modernismo. A mio giudizio, la si potrebbe inquadrare come una precorritrice della filosofia della tecnologia che però, non rimanendo entro le barriere determinate dall’accademismo, ne sfida le traiettorie precostituite, inaugurando il filone euristico delle environmental humanities.
Per interpretare la complessità del suo itinerario speculativo occorre fissare quei concetti chiave che, come perni, costellano le ardite trame teoriche. Secondo Haraway nessuna epoca si può definire moderna giacché non esiste un’origine, né un culmine che costituisca l’epifania della modernità. Questa assunzione lascia in un vicolo cieco tanto l’approccio storicista e storicistico — i quali fanno appello alle grandi narrazioni dotate di compiutezza —, quanto sbarra il passo all’aspetto antropocentrico sia esso specista, residuo del positivista, sia dottrinale religioso. Chiudendo all’idea di modernità, si esclude anche la categoria del post-moderno, infatti il post-moderno ha come sua condizione di esistenza cronologica e logica la modernità stessa: laddove i confini della prima si dissipano, la post-modernità non ha più alcuna ragione di esercitare la sua funzione critica nei confronti della modernità. Benché l’intento di Haraway sia quello di sottrarsi a questa corrente culturale, la sua filosofia ne è pienamente erede nella misura in cui è fortemente influenzata dal prolifico pluralismo, dallo stile talvolta ironico, dalle derive post-strutturaliste. Anche il carattere dell’indagine, ché si orienta verso lo spazio del virtuale e del possibile a dispetto dei grandi sistemi metafisici, è di retaggio post-moderno. Dunque la presa di distanze dal post-modernismo appare più formale che non sostanziale.
Come intendere il mondo se a sostenerlo non vi è più il puntello storico del progresso?
Il mondo è immerso nelle cose, le stesse da sempre, le quali sono in un intreccio di relazioni. Da questo caleidoscopio di attanti e attori ha luogo una serie di possibilità semiotiche che solo un pensiero laterale può investigare con una propizia profondità. Ne consegue che solo una visione a-moderna, cioè asettica storicamente, è sostenibile. Tale prospettiva squalifica le aspirazioni antropocentriche di un ipotetico progresso che da un’origine, passando per un’illuminazione, converge verso un fine. Per questa ragione la cifra distintiva del pensiero di Haraway è la relazionalità. Una relazionalità satura di interdipendenze, inter-azioni e cooperazioni, come in un discorso costante e perpetuo che coinvolge la totalità dei viventi. Umani e non-umani sono dotati della stessa dignità e potrebbero essere sussunti nella sovracategoria di terrestri: essa, nella sua estensione semantica, raggruppa l’intera specie dei viventi abbandonando qualsiasi presunzione tassonomica e con ciò qualsiasi pretesa di gerarchia e dominio. Allora il mondo non è nient’altro che lo spazio di un discorso, un’assemblea a cui partecipano gli esseri dotati di vita.
Allo stesso modo la natura non è un concetto che presentifica i viventi da cui è formata, ma assume i contorni semiotici di un’arena discorsiva in cui sono in gioco tutte le forme di vita. La scienza d’elezione che studia la natura è la biologia: questa disciplina si fa carico di (ri-)costruire l’interazione tra viventi secondo un’articolazione semiotica, per cui la materia di studio non è preesistente al discorso, ma piuttosto ne è il prodotto. Dunque l’equivalenza ‘mondo=natura’ ha al suo interno una serie di relazioni tra attori e attanti che le scienze si incaricano di oggettivizzare. Questo processo epistemico si struttura secondo delle articolazioni, ovvero delle catene sostitutive, per cui gli oggetti dell’indagine sono rimpiazzati da nomi, nozioni e griglie categoriali. Ora, queste operazioni — dal punto di vista di Haraway — hanno delle criticità irrisolvibili che determinano lo smottamento stesso dei fondamenti della ricerca scientifica: quello epistemico di oggettività e quello politico di neutralità. L’esercizio della scienza è politicamente carico giacché la sua istanza conoscitiva tenta di oggettivizzare ciò che intimamente risulta inappropriato e inappropriabile [Inapproprite/d Others]: la soggettività dei viventi risulta esente da qualsiasi impegno vòlto a cristallizzarne i contorni e inscatolarli in istanze definitorie. L’espressione inappropriato/bile è mutuata dal cinema sperimentale di matrice femminista di Minh-ha, di cui Haraway spana l’alone semantico tanto da connotarci qualsiasi alterità che si opponga al modello antropocentrico, il concetto assume un valore altamente contestatario. Quindi l’identità risulta inafferrabile secondo gli schemi conoscitivi standard: essa è polisemica e polimorfa, pertanto non la si può stipare in alcuna datità, sfugge a qualsiasi trappola terminologica e non è possibile incastrarla in alcuna funzione.
Su queste basi la scienza deve riformulare le sue premesse epistemiche. La natura distillata dal discorso scientifico è convenzionale ai dogmi capitalistici che inscrivono ogni oggetto all’interno del paradigma appropriativo. Nondimeno la presunta oggettività ha in filigrana il presupposto epistemico teleologico, sia pure autotelico, che ne comporta una violazione stessa dell’oggettività: infatti, se l’indagine ha un fine, sia pur esso autenticamente conoscitivo, non è più neutrale. D’altro canto anche una concezione ingenua che valuta la natura come curatrice incorre nello stesso errore: essa interpella la dimensione antropocentrica e pecca di considerare il mondo alla stessa stregua di un produttore di merci, in quanto ente in grado di produrre (od offrire) oggetti per la sopravvivenza e prosperità umana. Qualsiasi visione di stampo capitalista ha lo scheletro dell’antropocentrismo a sorreggerne le condizioni di esistenza. Ma allora qual è una prospettiva adeguata in grado di inibire le derive conoscitive finora indicate? In primo luogo la natura va analizzata secondo delle simultanee coordinate spaziali e semiotiche. Essa è topos in quanto è il luogo in cui avviene la cultura pubblica che comprende l’interconnessione tra umani e non-umani; essa è altresì tropos, ovvero movimento, dislocamento, costrutto e artefatto. Questa composizione dimensionale ha la conseguenza di far sfumare le distinzioni tra ciò che è sociale e ciò che è naturale e ricondurre i due aspetti a una composizione artefattuale, per cui ogni elemento è provvisto di un indice relazionale.
Qualsiasi oggetto di analisi scientifica, in quanto inappropriato/bile, appare come un costrutto privo di un’intrinseca oggettività: esso — come osservato — è una descrizione mediata dal dispositivo delle articolazioni di catene sostitutive. Il prendere atto di questa parzialità che marca la ricerca scientifica è cruciale, un’assunzione tanto radicale causa un’alleanza dichiarata tra politica e scienza: la politica, riempiendo il vuoto lasciato dalla mancata oggettivizzazione, guida e orienta verso futuri desiderabili. Quindi, il cómpito del sapere è mappare le zone di interferenza, ovvero posizionarsi non più nel recinto epistemico appropriativo, ma aprirsi all’orizzonte degli esseri inappropriati/bili. La razionalità riflettente — che riproduce il medesimo secondo schemi riflessivi che replicano l’oggetto dislocandolo — deve cedere il passo alla razionalità difrattiva che si occupa di individuare i luoghi in cui le differenze si manifestano segnando gli effetti.
La sigla SF a cui ricorre Haraway è un poliedro semiotico: Science Fiction, Science Fabulation, String Figures, So Far; tutte queste espressioni rimandano al mondo del possibile, all’immaginazione, alla potenzialità di inaugurare nuove rappresentazioni che escano dall’autismo oggettivistico delle scienze dure e si collochino su versanti inesplorati che includano la realtà e le possibili traiettorie future. La scienza, gravida delle istanze contestatorie dell’inappropriato/bile, diverrebbe un laboratorio euristico che, prevedendo ed elaborando i possibili sviluppi futuri, si orienta nella direzione più auspicabile. La scienza è fantascienza, perché ciascuna ricerca parte da un’elaborazione di ipotesi e infila i dati in dei percorsi immaginativi.
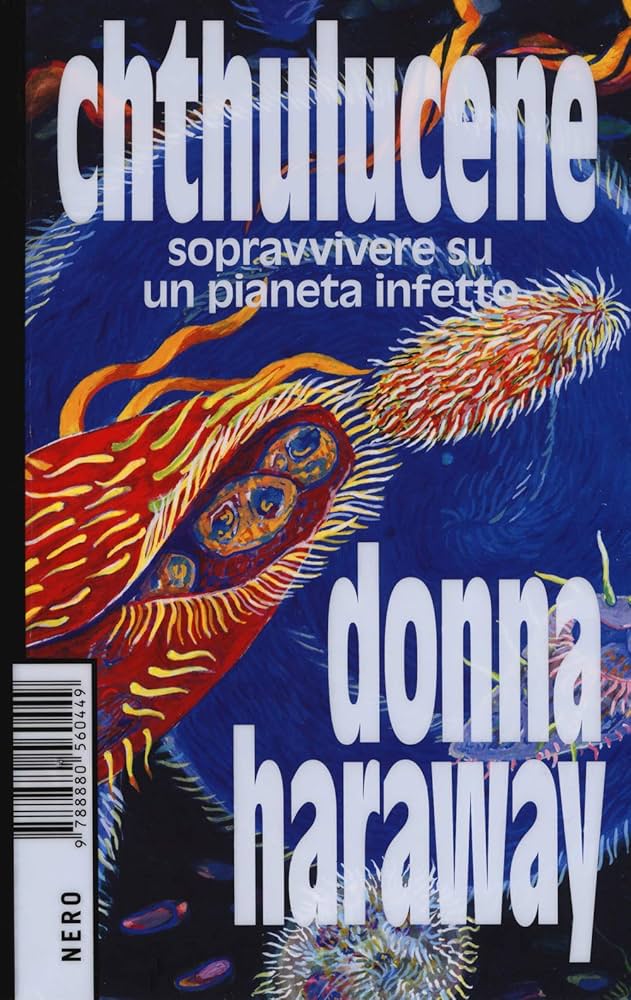

Lo spazio del dialogo che intende promuovere Haraway non è scevro da rischi.
Lo sbarazzarsi dell’antropocentrismo è portato alle sue estreme conseguenze al punto che la significazione tra vivente e la sua soggettività è squadernata nella teoria del Compostismo, ovvero una dissoluzione completa del soggetto che si direziona verso un piano ontologico omogeneo e massimamente aperto, al punto da annullare ogni gradualità gerarchica. Tutto diviene compost in un approccio eminentemente ecologico, all’insegna della simpoiesi ovvero “il fare insieme”. A fare da sfondo a una visione tanto drastica vi è il Chthulucene, ovvero un’epoca di estrema crisi ecologica, in cui ogni vivente diviene effettivamente un archeobattero: infatti, come un archeobattero, agisce e reagisce in un habitat ostile alla sopravvivenza.
In questo scenario apocalittico, monco però del suo risvolto escatologico, solo una coscienza politica informata dal compostismo può scongiurare questa pericolosa discesa. Stando a tale impostazione, l’essere umano non deve incarnare l’iconografia di un Homo sapiens che alza gli occhi al cielo, ma deve farsi Humus che partecipa allo scambio vivo (e contaminante) tra multispecie, accettando i rischi che ciò comporta.
***
Articolo di Sathya Cucco

Studiosa di filosofia e comunicazione, uso la conoscenza come compagna di vita.


