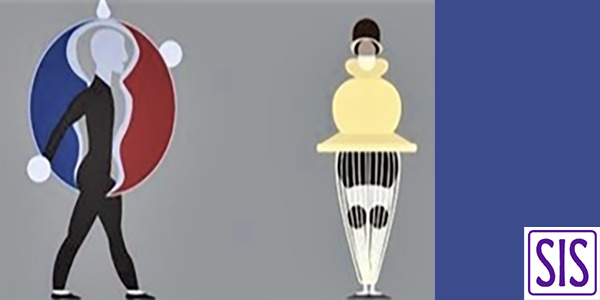La seconda lezione del corso di formazione online Migranti. Storie di vita, esercizi di relazione della Società Italiana delle Storiche segna un tragitto che è insieme storico-politico, geografico ed esistenziale. Il titolo dell’incontro, A Sud e a Nord. Campi profughi, centri di accoglienza e di detenzione, esemplifica, sintetizzandole, le tappe di questo cammino e, facendo combaciare la successione sintattica con quello temporale, preannuncia la torsione securitaria del diritto in materia e la conseguente mistificazione delle storie e delle vite delle persone immigrate.
A fare da cicerone in questo percorso di annientamento troviamo l’antropologa e docente presso l’Università di Torino Barbara Sorgoni che, da molti anni, si occupa di antropologia delle nuove migrazioni, in particolare delle/dei rifugiati in Italia, con un focus sulle procedure di selezione per il riconoscimento giuridico istituzionale delle/degli aventi diritto alla protezione internazionale e sulle pratiche di verifica delle storie di fuga, dei pregiudizi e dell’ignoranza sistematica che ne caratterizzano la lettura.
La figura di persone costrette a lasciare il luogo di nascita o dove abitualmente risiedono ricorre, plausibilmente, nella storia di tutte le popolazioni ma è solo nel 1951 che questa figura ottiene, finalmente, un inquadramento definitorio e giuridico. In quell’anno, spartiacque tra passato e presente, per la prima volta, viene messo a punto un corpus giuridico internazionale che stabilisce chi è una/un rifugiato e, dunque, chi può chiedere una protezione internazionale fuori dal proprio stato. L’art. 1 della Convenzione di Ginevra sancisce che: «Rifugiato è chi, nel giustificato motivo di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o per tale motivo, non vuole domandare la protezione di detto Stato» e aggiunge, all’art.33 che, qualora si verifichino tali condizioni, il Paese di accoglienza non può respingere la persona. Ciò disposto, si impone il problema della gestione. I campi di prigionia che fino alla fine della Seconda guerra mondiale erano gestiti militarmente vengono allora rifunzionalizzati e la logica e le pratiche che ne informano la conduzione diventano non più un problema militare ma umanitario. Si afferma così una modalità di gestione definita “forma campo”, ovvero la chiusura di grandi numeri di migranti in uno spazio delimitato in cui vengono accuditi e, allo stesso tempo, sorvegliati e dal quale non possono uscire liberamente.
Nasce nel 1951 anche l’Unhcr (United Nations High Commissioner for Refugees), principale istituzione per la gestione dei rifugiati a cui venne riconosciuta, dopo l’iniziale istituzione con un mandato di un anno e le riconferme successive, una vita sine die, senza termine o scadenza. Da quell’anno l’Unhcr persegue tre principali politiche: il collocamento nel Paese di approdo (settlement); il ricollocamento in un Paese terzo qualora quello di arrivo non sia considerato idoneo o non possa occuparsi di determinati numeri (resettlement) e il rimpatrio, nella cui definizione è stato recentemente aggiunto l’aggettivo “volontario” e che, di solito, viene gestito dall’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Da più di settanta anni, dunque, la risposta dell’organo deputato alla migrazione forzata è stata una sedentarizzazione altrettanto costretta.
Geograficamente inteso, il fenomeno delle/dei rifugiati ha inizio nel Nord del mondo; temporalmente parlando, alla fine della Seconda guerra mondiale. Durante il periodo di decolonizzazione (anni Cinquanta e Sessanta) si assiste a un’inversione di tendenza: la concentrazione maggiore si attesta al Sud per poi ricollocarsi al Nord a partire dalla fine degli anni Ottanta.
Al riposizionamento spaziale del fenomeno corrisponde una trasformazione del modo di concepire la/il rifugiato. Tra il 1948 e il 1967, quando i campi sono destinati principalmente agli europei e localizzati nel territorio del continente, i rifugiati, ovvero coloro che riescono a essere accolti e che sono gestiti dalla neonata Unhcr, vengono percepiti e definiti come eroi, membri di élite che, dopo aver partecipato alla resistenza ed essersi opposti ai regimi affermatisi nei diversi Paesi, sono riusciti a mettersi in salvo. Successivamente, quando il fenomeno subisce un’internazionalizzazione e comincia a riguardare principalmente il Sud del mondo, le/i rifugiati cominciano ad apparire come vittime sofferenti privi della capacità di provvedere a sé stessi.
Il riconoscimento di questo slittamento percettivo si deve, in particolar modo, all’antropologa americana Barbara Harrell-Bond che, in seguito ad una ricerca sul (e nel) campo destinato alle/agli ugandesi in Tanzania, realizza il primo studio di tipo qualitativo in merito (Imposing aid: emergency assistance to refugees, 1986). Tra i tanti aspetti che caratterizzano l’aiuto umanitario, la studiosa mostra la natura caritatevole dell’assistenza fornita nei campi: la modalità con cui quest’ultima viene elargita (il verbo non viene scelto casualmente) assume la forma non tanto di un diritto, come invece stabilito dalla Convenzione di Ginevra, quanto piuttosto di un dono che gli Stati finanziatori (definiti, non casualmente, doners) forniscono in una sorta di transazione meccanica che determina, inevitabilmente, una relazione che rimane simmetrica laddove non possa prevedere reciprocità. L’ottica con cui si offre protezione diventa quindi essenzialista e l’assistenza confusa con una generosità calata dall’alto che decide i modi dell’aiuto e stabilisce bisogni, desideri e possibilità generalisti, che prescindono da quelli individuali di ciascuno/a.
Nell’elaborazione di Harrel-Bond è esplicito il riferimento al lavoro di Marcel Moss. Nel suo Saggio sul dono (1925), Moss mostra come nelle relazioni basate sul dono, materiale o immateriale, sia la possibilità o meno di restituire quest’ultimo a configurarlo come tale o come carità. Così concepito, l’aiuto umanitario offerto nei campi del Sud del mondo riduce la figura della/del rifugiato non solo a vittima ma a una vita che deve solo essere nutrita come corpo biologico e non come persona dotata di capacità di azione e di scelta. In altre parole, i/le rifugiate divengono quelle che, recuperando la trattazione del filosofo Giorgio Agamben, taluni/e hanno definito nude vite.
Nel passaggio dalla teoria all’aiuto concreto, si opera quindi una distorsione del significato stesso di umanitario che, secondo la definizione dell’antropologa Miriam Ticktin, è, tra le altre cose, «un ethos, un aggregato di sentimenti, un insieme di leggi, un imperativo morale a intervenire, e una forma di governo. Nella sua caratterizzazione dominante, l’umanitario è un modo di fare del bene o di migliorare aspetti della condizione umana concentrandosi sulla sofferenza e sul salvare vite in tempi di crisi o di emergenza» guardando (aggiungiamo noi) alle specifiche necessità e storie di ogni persona.
A rammentare il loro status di persone dotate di agentività intervengono spesso le/gli stessi rifugiati. In questo senso, un esempio emblematico è rappresentato dal Refugee Flag Kakuma, un sottocampo del Kakuma Refugee Camp (Kenya, 1992) a cui hanno dato vita le/i rifugiati ugandesi Lgbtqia+. Fuggite/i dal loro Paese di nascita/residenza dopo l’approvazione della legge contro l’omosessualità, con la quale si sanciva la possibilità di effettuare uccisioni sommarie delle soggettività omosessuali e transgender, i rifugiati cosiddetti Sogi (Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum) si sono ritrovati in un contesto nazionale altrettanto repressivo, all’interno di un campo in cui non vigeva la legge che ne istituiva l’oppressione ma in cui, comunque, erano esposti agli attacchi delle altre persone presenti in quello spazio. Una situazione questa a cui l’Unhcr ha risposto richiedendo a quelle stesse soggettività di nascondersi e di usare discrezione per non generare tafferugli all’interno del campo. L’esito di questo silenziamento è stato, al contrario, un gran rumore: i rifugiati Lgbtqia+, attraverso la piattaforma statunitense GoFundMe, hanno avviato una raccolta di finanziamenti, usato i social per pubblicare le immagini delle loro storie e della mappa del campo e del sottocampo, fino a rendere possibile l’abilitazione di veri e propri resettlement gestiti dal basso. Quello del Refugee Flag Kakuma è un caso di restituzione di dignità a un luogo che porta inscritto in sé il suo annientamento.
L’antropologo francese Michel Agier definisce il campo come uno spazio extraterritoriale, eccezionale ed escludente. La prima qualifica si deve al fatto che si tratta di un luogo non necessariamente indicato nelle cartine ma sempre recintato dentro un determinato stato anche se non gestito dallo stesso. Da qui la seconda definizione: l’eccezionalità deriva dalle logiche e procedure che governano le persone rinchiuse al suo interno che non sono quelle dello Stato in cui il campo è situato ma quelle sovranazionali dell’Unhcr o delle Ong che vi lavorano. L’esclusione rimanda invece alla situazione di non appartenenza delle/dei rifugiati alla società circostante e alla paradossale spazialità che vige nei campi dove non è prevista la possibilità di spostamento e dove l’uscita dallo spazio circoscritto determina automaticamente la perdita di ogni assistenza e dello status di rifugiato/a. Ai paradossi di tipo spaziale si sommano poi quelli di natura temporale: sebbene l’intervento umanitario nei campi sia concepito come temporaneo, giustificato da una crisi o emergenza, esso è piuttosto, come da definizione di alcune/i, indefinitamente temporaneo dal momento che possono esserci persone e generazioni che nascono, vivono e muoiono nel campo.
Con la nascita dei centri di accoglienza nel Nord, dopo la caduta del muro di Berlino, si è assistito non solo a un incremento delle ricerche qualitative, frutto del timore di invasione, ma anche all’avviamento di un meccanismo politico di esternalizzazione delle frontiere, ovvero di una procedura di finanziamento a Paesi terzi col fine di bloccare l’arrivo dei migranti in Europa (si pensi agli accordi con la Libia, la Tirchia, il Niger e il Mali). Contemporaneamente si afferma il fenomeno della lotteria delle nascite che, di fatto, impedisce e non riconosce le/i migranti economici come forma legale di migrazione: le persone che si spostano dal sud del mondo per questioni economiche verranno automaticamente classificate come clandestine in quanto private delle possibilità di regolarizzarsi attraverso il lavoro; la regolamentazione viene vincolata alla richiesta di asilo e al possesso di documenti specifici o contratti di lavoro già avviati. Un tale meccanismo di sospetto formalizza tacitamente la necessità della menzogna: inventare storie di sofferenza e persecuzione diventa la conditio sine qua non per non essere rimpatriati/e.
L’isolamento spaziale, l’amministrazione di personale esterno e specialistico, così come procedure mediche igienico-sanitarie imposte e leggi e regolamenti specifici, insieme a diverse pratiche di controllo e verifica dei documenti, sono gli elementi caratterizzanti dei centri di accoglienza del Nord. La marginalità che li contraddistingue ha indotto alcuni/e a ritenere che la scelta della spazialità in determinati contesti sia funzionale a fornire forza lavoro facilmente sfruttabile. Alle distanze spaziali si assommano quelle temporali: lì nel limbo, le persone attendono fiduciose che la propria domanda di protezione internazionale abbia esito positivo. Ma quale destino attende queste persone se così non fosse? Cosa succede se il permesso o il visto è scaduto e non si riesce a rinnovarlo? Se non è sufficiente neanche il ricorso alla Corte di Appello? Si diventerebbe clandestine/i e, se intercettati dalla polizia, portati in un centro di detenzione, luoghi assimilati alle prigioni ma privi di quelle tutele, garanzie e diritti previsti dall’ordinamento penitenziario. Nei Cpr (Centri di Permanenza per i Rimpatri), a differenza delle carceri, non si accede perché si è commesso un reato penale ma amministrativo, è difficile accedere al supporto legale e praticamente impossibile comunicare con l’esterno o avere visite; inoltre, vige l’assenza di produzione di dati, come nel caso dei suicidi e dei gesti autolesionistici.
Dal 1990, anno in cui si è assistito alla nascita dei centri di accoglienza nel Nord del mondo, si parla sempre più di un’invasione delle/dei migranti in quella parte del globo, con particolare riguardo per il continente europeo. È un’impostura! Di 29.4 milioni di rifugiate/i meno del 10% è arrivato in Europa; oggi, rispetto alla popolazione europea, i/le rifugiate rappresentano lo 0.6% sia in termini assoluti che relativi.
Credo di potermi definire una religiosa delle parole; verso di esse, e ciò che significano, nutro un ossequioso rispetto; ne temo un uso sconsiderato e i tentativi mistificatori con i quali a volte si impiegano. Se allora mi soffermo sulla parola centro, parte della più ampia definizione “centro di accoglienza”, e se a quel centro attribuisco il significato di «la parte più importante, degna di attenzione, considerazione, cura», in nessun modo posso considerare quello spazio recintato e le persone che vi risiedono insignificanti. Anzi! È in rapporto a quel centro che io definisco il grado della mia umanità. Se ne glisso l’esistenza e le vite che vi abitano, le loro storie, io perdo l’essenza di me che mi differenzia dall’inumano. Se la disumanizzazione di chi è dentro è altro da me, non mi riguarda, se non nutro compassione ed empatia, posso ancora definirmi umanamente viva?
***
Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.