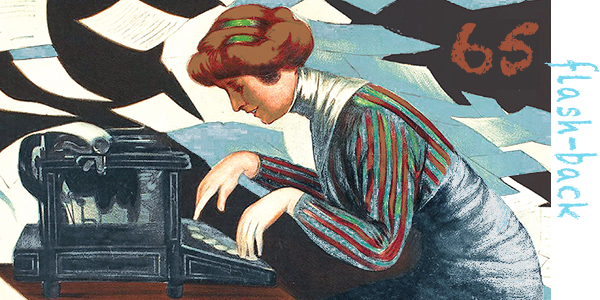Nonna Franca era nata a Firenze, in una casa stretta tra i vicoli che odoravano di pane caldo e glicine. Il suo sorriso — dicevano tutti — era quello di una che nella vita avrebbe portato luce. Nonostante la sua città le scorresse nel sangue, la lasciò molto giovane, seguendo il lavoro di Romano — l’unico amore della sua vita.
Si conobbero a tredici anni, in una piazza di paese dell’entroterra toscano — San Miniato, credo — durante una festa patronale: lui con i capelli pettinati all’indietro, le mani nelle tasche e quello sguardo da “grande”; lei con un vestitino a fiori e gli occhi pieni di curiosità. Da quel giorno, non si lasciarono mai.
Franca e Romano vissero tutta la vita insieme, affrontando guerre, traslochi, gioie e dolori come se fossero sempre la stessa coppia di ragazzi nella piazza — con la musica in lontananza e i cuori pieni di sogni.
Quando si trasferirono nelle Marche, Franca sentì mancare le sue radici fiorentine, ma fu proprio lì che mise su casa e famiglia. Ebbero tre figli, e uno di loro è mio padre. La casa — che oggi sembra immobile nel tempo — conserva ancora il profumo di lavanda, quella che metteva ogni mattina, anche solo per andare al mercato.
Nonna Franca ci teneva alla bellezza come si tiene a un segreto prezioso. Ogni giorno si pettinava i capelli con cura, metteva un filo di rossetto e portava orecchini abbinati — anche se doveva solo restare in casa. Diceva che la bellezza non era per gli altri, ma per sentirsi vivi.
Rideva spesso — anche quando c’erano problemi — e sapeva sdrammatizzare tutto con quella voce squillante, fiorentina ancora nel tono nonostante gli anni passati altrove.
Ma la parte più bella della sua storia l’ho scoperta solo dopo. Dopo la sua morte, tra i cassetti ordinati e le scatole colme di foto, ho trovato un fascio di lettere legate da un nastro rosso. Erano le lettere che lei e nonno Romano si erano scritti per anni. Alcune risalivano ai tempi in cui lui lavorava lontano e tornava solo nei fine‑settimana. In quelle parole c’era tutta la poesia di una vita condivisa: lui che le scriveva «mi manchi ogni mattina, come manca il sole alla campagna», e lei che rispondeva «non dimenticare il vino buono quando torni, ma soprattutto non dimenticare di stringermi forte».
Poi, in fondo alla scatola — sotto le lettere d’amore — ho trovato qualcosa che mi ha lasciata senza parole: un piccolo quaderno con la copertina rigida blu, pieno di riflessioni, ritagli e racconti scritti da lei. Una specie di diario, ma senza date, senza cronologia. Era come se avesse scritto per sé stessa — senza voler essere letta. Ma io l’ho letta lo stesso. E lì ho scoperto un lato di nonna Franca che non conoscevo.
Uno dei primi fogli diceva: «Quando Romano riceve la promozione, tutti lo applaudono. Quando dico che ho tenuto in piedi la casa, i bambini, la spesa e pure il giardino, mi dicono ‘sei una brava moglie’. Ma io non voglio solo essere brava. Voglio essere riconosciuta».
Leggevo e mi sembrava di sentirla parlare. Una voce diversa da quella allegra che ricordavo — più cruda, più consapevole. Un altro passaggio raccontava un episodio che non mi aveva mai detto: «Avevo vent’anni, cercavo lavoro. Il signore dell’ufficio mi disse che ero troppo carina per stare dietro una scrivania. Che avrei distratto i colleghi. Tornai a casa in lacrime, senza dire niente a nessuno. Mi vergognavo. Oggi mi arrabbio. Perché non era colpa mia».
E ancora, un appunto annotato in corsivo: «Quando una donna alza la voce, è isterica. Quando lo fa un uomo, è carismatico. Se metto un vestito elegante, lo faccio per me. Ma gli altri pensano che voglia piacere a qualcuno. Non mi sono mai sentita davvero libera di essere solo Franca. Sempre la moglie di, la madre di, la signora elegante. E invece io sono anche altro».
Quelle parole mi aprirono gli occhi. Era come se, leggendo, sentissi anche la mia voce echeggiare nella sua. Le sue frustrazioni sembravano le mie. Capivo all’improvviso quanto la sua generazione avesse dovuto lottare in silenzio — e quanto molte cose, purtroppo, siano ancora vive oggi.
Ma il diario non era solo rabbia. Era anche sogni, speranze, piccoli gesti di rivoluzione quotidiana. C’erano ritagli di poesie di Alda Merini, frasi cerchiate di Simone de Beauvoir, una foto sbiadita di lei con un gruppo di amiche a una manifestazione per il diritto al lavoro femminile negli anni ’70.
E poi, in fondo, una frase sottolineata tre volte: «Vorrei che un giorno mia nipote trovasse questo quaderno. E capisse che essere donna è ancora una battaglia. Ma che vale la pena combatterla con grazia, coraggio e ironia. Proprio come il rossetto, anche quando piove».
Mi vennero le lacrime agli occhi. La scatola di Franca non era solo un ricordo d’amore — era un’eredità. Una fiaccola passata di mano.
Oggi, ogni volta che sento profumo di lavanda, o vedo una signora che si mette il rossetto anche solo per buttare la spazzatura, penso a lei. Alla sua eleganza semplice, al suo amore eterno — ma anche a quella rabbia educata che portava dentro e che ora, forse, ho raccolto io.
Conservo il quaderno come un testamento. E ogni volta che mi sento fuori posto, o messa da parte solo perché donna, lo apro. E leggo. E sento Franca sorridere.
***
Articolo di Lucrezia Pratesi

Studente di Lingue e culture moderne con indirizzo di Lingue per l’impresa presso l’Università di Pavia. Amante della letteratura, degli animali, della cucina vegetariana e del viaggiare alla scoperta di nuove culture e lingue.