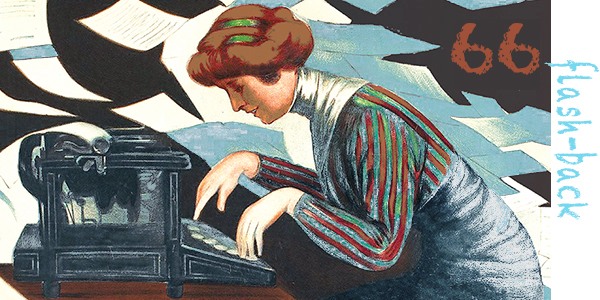Ogni tanto l’avevo visto girovagare nella mia zona. Una cifosi accennata sormontava la parte alta della sua spina dorsale e costringeva il suo corpo a camminare sbilenco. Le spalle larghe rassomigliavano al bilico di una bilancia, le lunghe braccia ciondolanti alle funi che sorreggono i piatti. In questa bascula in carne e ossa, il carico protendeva a destra e il giogo sulla sommità pareva troppo fragile per farla funzionare correttamente.
La gente del quartiere raccontava che fosse innocuo, che di lui non c’era d’aver paura. «È vero, ha delle denunce per atti osceni in luogo pubblico e ogni tanto — aggiungevano senza il tono gravoso che gli sarebbe stato appropriato — segue le ragazzine e, da dove loro non possono vederlo, le fissa e si masturba, ma non si spinge mai oltre» … Io, all’epoca, ero una ragazzina.
Nonostante quanto si dicesse in giro, di lui avevo paura ma mi rassicurava il fatto che lo vedessi sporadicamente e che, quando succedeva, io ero nella condizione di poterlo guardare senza che lui potesse fare altrettanto con me. Purtroppo, però, quel giorno i ruoli si sono invertiti: lui ha poggiato su di me il suo sguardo e io l’ho sentito addosso, pesante come il soffitto di cemento armato sopra la mia testa.
Il sottopassaggio, dietro le cui colonne lui si nascondeva come un cecchino, a quell’ora era deserto; la luce alla fine del tunnel sembrava irraggiungibile nonostante i miei passi si facessero sempre più rapidi. I tacchi bassi dei miei stivali mi sembrarono improvvisamente degli spilli di dodici centimetri: mi maledicevo per la vanità che quella mattina, per la prima volta, mi aveva fatto preferire quelle scarpe alle mie amate e agili sneaker. Imprecavo contro il fato, non per lui ma per il manico della sacca che conteneva il mio dizionario di latino: il maladetto si ruppe, costringendomi a privare la mia fuga di secondi preziosi che dovetti destinare alla raccolta del tomo.
Lui mi stava dietro, abbastanza vicino da sentirne i passi, sufficientemente lontano da sembrare un qualsiasi pedone intento esclusivamente a percorre il suo cammino.
Ce la faccio! Vedo casa mia e affretto il passo: il mio posto sicuro è a pochi metri di distanza. Nel tragitto prendo le chiavi del mio Eden; arrivo davanti al cancello e lo apro di tutta fretta: sono salva! Tutto il mio corpo è invaso dal battito accelerato del mio cuore; la mia testa non so dove sia. Mi affaccio dalla finestra del mio salone e lo vedo lì, fermo davanti al mio cancello. Ora che sono nuovamente io a guardare lui, dall’alto del mio appartamento al terzo piano, mi sento di nuovo protetta… ma le mie gambe tremano e, d’ora in poi, avrò paura perché lui sa dove abito.
L’ho rivisto una sola volta e poi mai più, credo per interferenza di mio padre: sono sul sedile del passeggero e mi sono fatta piccola, lui se ne accorge e mi chiede spiegazioni; gli indico quell’uomo sbilenco e gli racconto l’accaduto. Papà mi lascia a casa e poi svolta veloce l’angolo e lo raggiunge… Non ho mai chiesto che cosa gli avesse detto.
Da quel giorno, comunque, odio il latino con l’intensità di mille soli e indosso i tacchi solo se in compagnia. D’altronde, non ho mai visto nessuno/a sfuggire alla persecuzione indossando delle belle décolleté.
Ogni tanto ripenso a quello che è successo e mi dico che, tutto sommato, sono stata fortunata. Non c’è nulla di buono in tutto questo: sentirsi fortunata perché sono riuscita a scappare da un potenziale aguzzino significa compiacersi del male minore. E il male possibile non dovrebbe adombrare la mia mente, intercedere tra me e il mondo; dovrei poter andare con gli occhi ritti sul cammino e invece le mie pupille ruotano attorno al mio corpo incessantemente, cercando tutti i pericoli da cui potrei doverlo proteggere, insieme alla mia anima.
Però ci penso e comunque mi dico che sono fortunata: lo sono stata quando la mia casa mi ha dato riparo. Perché penso a una bambina di undici anni che, come me, è arrivata alla porta del suo Eden e si è sentita sicura di poter abbassare le armi, finalmente salva; e invece lui è entrato e ha profanato il suo corpo, la sua fanciullezza e il suo posto sicuro nel mondo.
Perché penso a quelle donne per cui la casa è il luogo delle sopraffazioni e delle violenze, il luogo da cui vorrebbero sfuggire e che, al contrario di me, lo guardano e vedono il buio e non la luce.
Perché penso alle giovani donne che invece di chiamarsi per organizzare il prossimo incontro di giochi, devono chiamare i soccorsi per salvare la propria madre che giace in uno stato agonizzante per colpa del loro padre. E quindi si, penso e mi dico: sei fortunata!
E mentre la mia mente è assalita dai pensieri, mi chiedo se per le donne ci sia davvero un posto a cui poter associare il significato simbolico che attribuiamo alla parola casa, mi chiedo, insomma, se c’è davvero, per noi, un posto sicuro nel mondo. E mi rispondo che sì, c’è, ed è quello intangibile che creiamo quando siamo insieme, perché le strade sicure le fanno le donne che le attraversano (e Dio solo sa quanto mi rassicura avere solo anche un’altra donna lungo la mia via), perché le nostre porte saranno sempre aperte per le altre e perché, alla fine, insieme siamo una forza!
***
Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.