La carrozza sferraglia sopra la strada dissestata. Al suo interno una giovane Anna Rolli siede vicino al neosposo, il medico Giovanni De Michele, con la testa poggiata al finestrino; ha gli occhi stanchi e le ossa intorpidite dal lungo viaggio che da Roma l’ha condotta a Bitonto, la terra del marito.
Il cocchiere tira le redini e i cavalli si arrestano; ora gli occhi della ventenne poggiano su “La Romana”, la lussuosa dimora che l’accoglierà negli anni a seguire. Anna ha adibito una stanza della villa a officina d’arte: tra quelle mura la vedo indaffarata tra pennelli, colori e tele bianche. Sta lavorando ad Amor materno, il quadro che, insieme a Innocenza e alle due copie del Raffaello, la Madonna di Foligno e la Madonna del cardellino, le varranno la vittoria della medaglia d’oro della Società promotrice di Belle Arti della città di Bari, nel 1841. Sarà una delle poche donne a vincerla… e come poteva essere altrimenti? D’altronde Anna si era distinta per il suo talento già anni prima quando, a soli quindici anni, aveva esposto la Miracolosa guarigione del cieco Tobia in Campidoglio, guadagnando menzioni sul Giornale Romano e Giornale Arcadico di Scienze, Lettere e Arti: «In primo luogo vogliamo lodare la sig. Rolli d’aver seguito per quanto era in lei il metodo della nostra buona antica scuola, a cui è d’uopo che ricorrà chi vuol vedere i suoi dipinti conservati e degni di conservarsi. Non si vedono perciò in quel suo quadro né certi neri, né certi giallastri, né tampoco certe negligenti pennellate che alcuni chiamano fierezza di tocco: le quali cose tutte riprovate dai nostri antichi sono oggi in onore presso alcuni meno avveduti».
Prima di spegnersi, a soli trentacinque anni, Anna si dedica anima e corpo alla sua arte, realizzando opere a sfondo religioso, come alcune pale realizzate per la Chiesa di San Giuseppe di Palo del Colle e quella per la chiesa del Purgatorio a Bitonto con La Trinità, la Vergine e le Anime purganti dove inserisce il suo ritratto, quello del marito, del naturalista Sebastiano Rolli, suo padre, e due suoi due figli.
Dall’entroterra mi sposto verso la costa adriatica, in direzione di Bari; qui incontro Maria Mundo. Il grembiule, sotto il quale si intravede il vestito a scacchi blu e, sul davanti, un piccolo fiocco verde, le avvolge la vita sottile, strusciando lungo la cartella tenuta con la mano destra. Prima di entrare nella scuola di pittura a cui è stata iscritta dai suoi genitori, Anna si ferma sui gradini di travertino, rotea il busto di novanta gradi e saluta suo padre Giosuè, il sindaco della città.
Gli anni della sua fanciullezza scorrono veloci sotto i miei occhi: mentre lei si fa grande, vedo la sua arte evolversi, affinarsi e mi sembra che la maturità personale vada di pari passo a quella artistica, fino a raggiungere l’apice e a combaciare perfettamente nel 1861. È l’anno della prima Esposizione Nazionale di Firenze, la grande mostra del neonato Regno d’Italia che il re Vittorio Emanuele II ha inaugurato il 15 settembre. Quattro dei dipinti di Maria, incluso un ritratto del padre, sono ammessi al grande evento espositivo. I soggetti floreali e la natura morta sono i grandi protagonisti dei suoi dipinti.

È il 1835. Seduta accanto al marito Luigi, comandante della gendarmeria di Lecce, la nobildonna Luisa Palombi si cinge il ventre che ha iniziato a contrarsi. Poche ore dopo — che per me sono istanti racchiusi in fotogrammi — viene alla luce Clementina Carrelli. Scorro le immagini che si susseguono e la vedo mentre ricopia su tela le opere degli autori classici sotto la guida del pittore tranese Biagio Molinari, dedicatario della sua prima opera. A Roma, dove mi ritrovo seguendo i suoi spostamenti, la sgorgo mentre osserva ammaliata le sculture dalle città; per lei è come un’epifania: in quei giorni di esplorazione nasce in Clementina la passione per la scultura e la volontà di mettere il suo talento a servizio di questa arte minore. Di lì a breve assisto alla sua consacrazione artistica: è il 1859 quando la giovane donna espone l’opera Agar e Ismaele alla Mostra di Belle Arti nel Museo Borbonico di Napoli. Poi da qui ci spostiamo a Vienna per l’Esposizione Universale del 1873; torniamo a Napoli per quella del Settantasette; da lì risaliamo verso Torino per partecipare all’Esposizione Generale del 1884 e poi alla volta di Londra per quella Italiana del 1888.
Per seguirla nei suoi spostamenti ho girato il mappamondo tra le mie mani incessantemente, seguendolo con i miei occhi che ora si sono fatti stanchi, al punto da non accorgermi che, nel frattempo, lei si faceva anziana. Ma ora, a Napoli, mi rendo conto che è passata una vita: è il 1916; Clementina esala l’ultimo respiro mentre io recupero il fiato che è riuscita a rubarmi la sua arte e la sua esistenza vivace.
La ricorderò a Lecce, in quella strada che porta il suo nome.

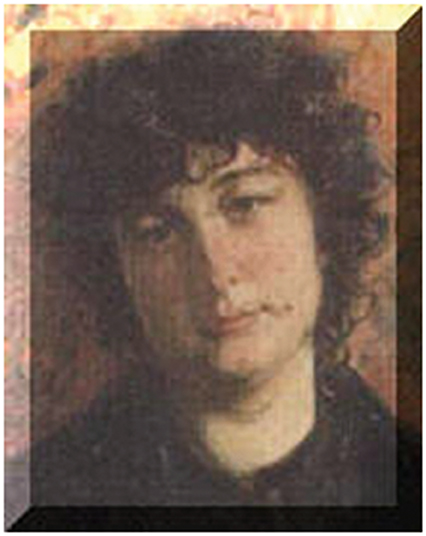
Succedendo al padre della patriota Antonietta De Pace, Richard Stevens diventa viceconsole inglese di Gallipoli nel dicembre del 1828, trasferendosi da Malta insieme alla moglie Emmanuela Fontani, alle sue quattro figlie — Elizabeth, Marianna, Matilde e Augusta — e al primogenito Henry. C’è di importante che quest’ultimo, nel 1842, sposò Carolina Auverny e che dalla loro unione nacquero tre figlie e due figli, di cui la secondogenita, Carolina Sofia, è la donna di cui sento l’attrito della penna sul foglio.
Avviata prima alle scuole del Conservatorio delle Suore di carità di Galatina, l’unico istituto che forma anche fanciulle, e poi presso il famoso istituto femminile napoletano diretto di Carolina Cordella, la ritrovo nella sua città natia quando ha già quindici anni, intenta nella scrittura dei suoi primi componimenti poetici, e poi di nuovo, dopo due anni in giro per l’Europa, quando assume l’incarico di ispettrice delle Scuole Femminili.
«E perché ciò fare, se fra poco non sarò più?»… Sappiamo entrambe — e lei lo scrive chiaramente in una missiva inviata all’amico Federico Villani — che il cancro che le è stato diagnosticato a ventotto anni non le lascia scampo ma, forse consapevole che sarà ancora proprio grazie alle sue opere, Sofia non smette mai di comporre. Si dedica alla scrittura ardentemente, «svelta e geniale sempre nelle ispirazioni», facendo tesoro «di qualsiasi argomento, (…) canta, con tanta ispirazione, con tanto sentimento e con tale leggiadria ed originalità di immagini e di concetti che giunge talvolta a destare ammirazione nel lettore, spesso a commuoverlo con la nota dominante delle sue sventure, spesso ad entusiasmarlo con la vivacità dei suoi amori e delle sue rime». Poi la fine giunge, il 10 agosto del 1876. Ma come non si aspettava — o come forse aveva intuito — lei è ancora: «la ultima e più soave Camena gallipolina, dalle fattezze elleniche, dal cuore di Saffo» vive nelle 350 poesie, poi pubblicate sotto il titolo Canti, che ci sono pervenute.
Addio bel mare, che di cobalto tinto
Doni amoroso bacio a questa sponda,
Mentre la terra, da cui sei recinto,
Varia si specchia in tua mirifica onda.
Io nel vederti sento il core vinto
Da molti affetti, ed una stilla inonda
Il guardo mio, che tanto resta avvinto
Ne la cèrula tua acqua profonda.
Pur m’è forza lasciarti, o Ionio mare,
E ad altra terra andar col mio diletto;
Più quivi io non vedrò tue spume chiare
Bagnar i piedi del paterno tetto,
E solo ahimè tra le memorie care
Palpitar per te potrà il mio petto
(Il mare Jonio, Sofia Stevens)
Arrivederci Puglia; arrivederci amiche mie…
***
Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.


