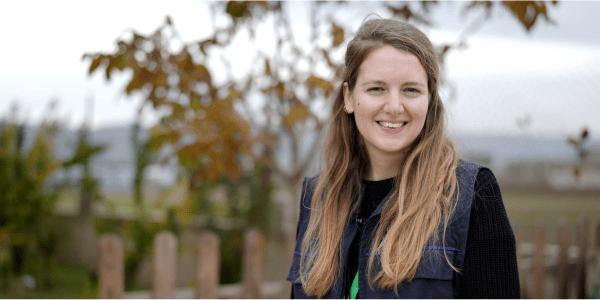Alice Boffi, trentatré anni, laurea in Mediazione linguistica e culturale (Università Statale di Milano), master in lingua inglese in Politica globale e relazioni internazionali (Università degli Studi di Pavia), parla correntemente inglese e diversi dialetti arabi, lavora attualmente in Giordania per UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di soccorso e occupazione per le persone rifugiate palestinesi nel Vicino Oriente.
Qual è stato il tuo percorso di studi e quale motivazione ti ha portato a intraprenderlo?
Il mio percorso è stato caratterizzato dallo studio delle lingue, a partire dal liceo: ho studiato inglese, francese, spagnolo; poi, durante la triennale, ho allargato il mio orizzonte alle lingue orientali, in particolare alla lingua araba; i dialetti arabi con cui ho maggiore familiarità sono quelli dell’area del Levante: libanese, siriano, palestinese, varianti tra loro molto simili.
La motivazione è stata una grossa curiosità per tutto quello che è diverso, che mi ha sempre attratto, mai respinto o impaurito. Amo l’avventura: quando ero bambina la mamma diceva che ero incosciente, avevo scarso senso del pericolo, ero e sono istintivamente attratta dalla diversità. Ho una vera passione per i paesi esteri, mi piace viaggiare ed esplorare il mondo, amo conoscere tradizioni, lingue, culture differenti; a questo si unisce la passione per il volontariato e il servizio a favore degli altri.
In passato sono stata attiva in varie opere di volontariato cittadino: sono stata animatrice all’oratorio, mi sono dedicata alla cura delle persone con disabilità, ho insegnato italiano agli stranieri, poi mi sono impegnata nell’accoglienza a rifugiate e rifugiati siriani alla Stazione Centrale di Milano, negli anni in cui è iniziata la guerra, 2013 e 2014. Mi hanno mosso la curiosità, l’amore per le lingue, che volevo conoscere e parlare con scopi sociali.

Il mio corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale è una sorta di interfacoltà tra lingue, lettere e scienze politiche; è stato molto interessante, ma ho scelto di non continuare su quella strada perché mi sono resa conto che c’erano moltissimi ragazzi e ragazze di seconda generazione che parlavano arabo e, rispetto alla loro, la mia competenza era più debole. Questa consapevolezza mi ha portata a scegliere una laurea magistrale che ampliasse la prospettiva rispetto alla mediazione. Dunque, ho optato per la cooperazione internazionale, con aperture a diplomazia e giornalismo; non mi era possibile studiare all’estero, perciò mi sono iscritta a un corso di laurea magistrale sì in inglese, ma in Italia, a Pavia. È stato un bellissimo percorso, improntato a un metodo anglosassone (è privilegiata la produzione scritta), interessante non solo per le materie ma per l’approccio culturale; ero inserita in una classe di una trentina di persone nella quale meno della metà italiane; le altre provenivano da diversi paesi europei, dal Vicino Oriente, dall’Africa…
Al secondo anno ho avuto la possibilità di partire per l’estero con una borsa di studio per compiere ricerche per la tesi o effettuare stage sul campo: una definizione ampia; era però necessario trovare un ente che si impegnasse ad accogliermi, una Ong che mi prendesse per cinque o sei mesi. Avevo la curiosità di provare il mondo della cooperazione, in un framework ancora protetto: sarebbe stato un elemento in più per capire che fare dopo la conclusione degli studi. Non è stato facile trovare una Ong che mi accettasse da studente; anche grazie a qualche contatto, ho trovato Fondazione Avsi, con cui ho lavorato una volta conseguita la magistrale, negli otto anni successivi.
Ho scelto di andare nel mondo arabo, nell’area del Levante, la mia passione; ero già stata due o tre volte in Palestina, poi in Libano. Sono partita nel marzo 2015: è stata un’esperienza importante che ha preparato il mio ingresso nel mondo del lavoro, protetta, ma sul campo. Nel dicembre 2015 mi sono laureata con una tesi proprio su questa esperienza e ho concluso il mio percorso di studi.
In quali paesi e a quali progetti hai lavorato dopo la specializzazione?
Dopo la specializzazione sono ripartita per il Libano, per un tirocinio su un grosso progetto finanziato da Unicef, di sostegno a rifugiate e rifugiati siriani in territorio libanese attraverso la fornitura di servizi di base: approvvigionamento di acqua e cibo, salute, educazione; in particolare, ho lavorato con il capoprogetto per la protezione dell’infanzia. Poi, sono stata fortunata: una persona ha lasciato Avsi nel dicembre 2015 e nel gennaio 2016 io sono diventata responsabile del progetto all’interno del quale, qualche mese prima, avevo fatto lo stage.
Da assistente a capoprogetto: un salto eccessivo, non ero preparata, ma era un biglietto della lotteria che non potevo rifiutare. L’inizio è stato duro, la gestione del progetto difficile, ma l’esperienza di apprendimento è stata enorme. Alla fine del 2016 ho concluso il mio lavoro in Libano e mi è stato offerto di continuare in Giordania: qui ho lavorato nel 2017, 2018 e fino al luglio 2019 nella gestione di progetti di interventi di risposta umanitaria nell’ambito della crisi siriana, progetti di scopo sociale, di educazione e protezione dell’infanzia, finanziati dall’Agenzia italiana per l’educazione allo sviluppo. Si trattava di dare sostegno a bambine e bambini rifugiati, attraverso attività psicosociali, ricreative, sportive, culturali, e anche alle persone che ruotavano intorno a loro: la famiglia, la scuola, la comunità. Il focus, dunque, era sull’educazione e sul benessere, due declinazioni dello stesso tipo di intervento: educare e proteggere e viceversa. È stata, questa, un’esperienza molto bella, in una missione più piccola: davo una mano nella gestione della missione, scrivevo le proposte di progetto, mi relazionavo con i donatori.

Nell’agosto 2019, su mia richiesta, sono rientrata in Libano come capoprogetto (dal 2016 sono legata a una persona libanese) e sono rimasta nel paese fino al gennaio 2023, per più di tre anni; ho continuato a occuparmi delle stesse cose, ma visto che ero cresciuta, sono diventata coordinatrice di tutti i progetti di educazione, con una responsabilità maggiore, e sono arrivata a essere direttrice di tutti i programmi per l’infanzia. Nell’ultimo anno e mezzo, lavorando da remoto, sono stata responsabile del sostegno a tutto il Vicino Oriente, anche al Kurdistan irakeno, uno stato dentro lo stato, con una identità particolare rispetto al mosaico che è l’Iraq.
Dall’aprile 2023, lavorando per UNRWA, ho allargato lo sguardo ad altri paesi per i quali non avevo mai lavorato prima, nell’ambito di un programma finanziato dal Regno del Belgio: Libano, Giordania, Siria, West Bank (ovvero la Cisgiordania, i territori occupati ove si trovano le città di Ramallah, Nablus, Hebron), striscia di Gaza. Quest’anno sono stata in Siria per la prima volta, è stata un’esperienza molto bella, e prima di Natale andrò sia in West Bank che a Gaza.
La Palestina, e la questione palestinese, sono nel tuo cuore. Vuoi raccontarci?
Il mio amore per la Palestina è nato da quando ci sono stata. Mi aveva incuriosito per il suo fascino e la sua complessità, ma la vera passione è nata da quando ho visto con i miei occhi quello che succede: impossibile rimanere indifferenti. Si pensa alla questione palestinese come a una questione di una complessità inestricabile: ma constatare la realtà del drammatico squilibrio nelle forze e nella violenza, che nella maggior parte dei casi è unilaterale e sproporzionata, semplifica tutto, fa provare l’urgenza di fare qualcosa, di parlare e sensibilizzare quanto più possibile.
Nel 2013 avevo effettuato un viaggio di piacere in Israele con la famiglia, a cavallo sia dello stato israeliano che dei territori occupati. Già grazie a qualche scambio europeo avevo conosciuto alcuni ragazzi palestinesi, che avevo trovato culturalmente ricchi e interessanti, vitali, con storie e vissuti pesanti, e avevo fatto amicizia con loro. Durante il viaggio, avevo visto i check point e il muro, incontrato persone che vivono in prigioni a cielo aperto. Non credo sia sbagliato andare in Israele, ma non si può recarsi nel paese e fare finta che a trenta chilometri non ci sia un’altra realtà, completamente diversa. I territori occupati vivono un’ingiustizia quotidiana da trent’anni: sono tante le storie che ho ascoltato, non di persone combattenti, ma di una popolazione che vive in uno stato di prigionia e di privazione totale. Una volta che si è stati testimoni, è impossibile rimanere indifferenti a una causa così infinitamente giusta.
Nel mio lavoro, spesso, mi pongo dilemmi di carattere etico: «Faccio bene? Aggravo la dipendenza delle persone? In che misura il sostegno è utile?». Sì, il mio è un lavoro pesante dal punto di vista delle domande. Ebbene, la Palestina è un luogo in cui queste domande cessano di esistere: hai la consapevolezza che stai facendo la cosa giusta.
Sono tornata in Palestina altre due volte per studio e per volontariato: a scuola studiavo l’arabo standard (quello usato dai media), mentre la gente nella quotidianità parla dialetto; avevo urgenza di parlare con la gente… Ho affrontato la mia prima esperienza di volontariato a Betlemme, nel 2014, la seconda a inizio 2015. Dopo l’inizio della mia carriera professionale, sono tornata in Israele nell’aprile 2019, attraversando il confine della Giordania, e tornerò in Palestina nei prossimi mesi.
Ora sei in Giordania e lavori per una agenzia delle Nazioni Unite. In che cosa consiste il tuo lavoro? Vuoi descrivere una tua giornata standard?
Unrwa è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di soccorso e occupazione a favore dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, di educazione, salute, assistenza sociale. È stata creata tra le prime, grazie a una risoluzione del 1949, all’indomani della guerra seguita alla fondazione dello stato di Israele, nel 1948; a breve compirà settantacinque anni, e di questa agenzia continua a esserci bisogno in assenza di una soluzione politica alla questione palestinese.

Io lavoro nell’ufficio centrale, nell’head quarter Unrwa di Amman, in Giordania. Concretamente mi occupo della gestione di un progetto che risponde a bisogni di emergenza nei cinque paesi in cui vivono rifugiati palestinesi (Libano, Giordania, Siria, West Bank e striscia di Gaza); sono capoprogetto, con funzione di coordinamento e supervisione del programma. Effettuo riunioni con il mio staff, facciamo il punto della situazione su come procede il progetto, su quali sono gli ostacoli, le sfide, le problematiche, i risultati raggiunti; faccio chiamate a colleghe e colleghi che si occupano del programma in ciascuno dei paesi coinvolti; e poi altre riunioni, di aggiornamento del piano del progetto, di messa a punto della reportistica per il finanziatore… Lavoro con la mia responsabile diretta, una persona di origine palestinese, su aspetti che vanno oltre il programma specifico, nella redazione di documenti, nel coordinamento con altri. È un lavoro di ufficio, di contatto, di supporto; sul campo ci sono i front-liner, in prima linea, assistenti sociali, psicologi e psicologhe, che sono persone locali. Lo staff internazionale raramente fa lavoro sul campo, opera sulla qualità dei programmi. Si va sul campo a seconda della grandezza dell’organizzazione in cui si lavora: con Avsi mi muovevo due volte la settimana, con Unrwa è diverso: in un anno compio una missione per ogni paese, dunque cinque missioni.
Eri a Beirut il 4 agosto 2020. Vuoi inquadrare la tragedia dell’esplosione al porto nel quadro della situazione libanese?
È una domanda impegnativa, l’esplosione del 4 agosto è stata, anche per me, un evento traumatico. E per rispondere è necessario fornire un quadro di riferimento.
Il Libano è un paese grande come l’Abruzzo, ha circa sei milioni abitanti, confina con Siria e Israele, stati più forti dai quali è come schiacciato. Tra il 1975 e il 1990, per quindici anni, è stato dilaniato dalla guerra civile; nel 1982 la parte meridionale è stata invasa da Israele, poi, dal 1990, ha subito l’influenza della Siria, ma al contempo ha avviato una fase di ricostruzione complessa, e dal 2005 anche di emancipazione. In seguito alla guerra civile in Siria, nel 2011, è iniziato un incessante flusso di profughi, tanto che ora il Libano è lo stato con il più alto numero di rifugiati nel mondo: si calcola che vi sia circa un milione e mezzo di siriani (ma forse anche un milione e ottocentomila). Questo ha determinato una pressione insostenibile sui servizi di base libanesi, a fronte della quale la comunità internazionale si è mobilitata, ha dato una risposta di emergenza.
L’economia, in apparenza fiorente, era in realtà fragile: il Libano importava e importa il 90% dei beni ed è mantenuto dalle rimesse dei dodici o tredici milioni di suoi cittadini emigrati all’estero; vanta eccellenze nelle banche, nelle università, negli ospedali (ma, per esempio, il settore edilizio è assolutamente fuori controllo, senza regole): nel settore dei servizi, dunque, non nell’industria, perché il paese di fatto non produce nulla. Si è creata una bolla finanziaria che nell’ottobre 2019 è scoppiata: il sistema economico è crollato e si è innestata una fortissima crisi, politica, sociale, energetica, che si è sommata alla crisi siriana. Il paese è stato attraversato, e lo è ancora, da crisi multiple e diverse: perdita di valore della moneta, blocco dei risparmi e dei prelievi, inflazione alle stelle, classe media impoverita, diseguaglianze fortissime: c’è un piccolo numero di superricchi, mentre l’80% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. A questo si aggiunge una grossa instabilità politica, che ha portato a grandi manifestazioni popolari di protesta; in Libano vige un sistema di affiliazione settaria del potere, basato su categorie identitarie, religiose o ‘etnico-culturali’, un sistema incredibilmente corrotto che genera immobilismo sociale. Anche per questo la gente è scesa in piazza, poi ci sono state la pandemia e la risposta violenta dello stato. Un quadro complesso, dunque, di un paese allo stremo.
Il 4 agosto 2020, nel porto di Beirut sono scoppiate 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio, stoccate in condizioni di assoluta insicurezza. Io vivevo allora a Jounieh, sedici chilometri a nord di Beirut, ove ha sede Avsi, per la quale lavoravo.
Entro nel mio appartamento, al sesto piano di un palazzo bruttissimo, alle 18.00. C’è la crisi energetica, l’ascensore non funziona, ho fatto le scale a piedi, entro in casa e mi schianto sul divano. Alle 18.05 inizio a sentire una scossa, penso che ci sia un terremoto e vado verso il balcone per vedere se la gente scende in strada. Sento un rumore indescrivibile, un fragore violentissimo: partono tutti gli allarmi delle auto, è un rumore infinito, come se si fosse spaccato il mondo. Penso: «Israele attacca, sta bombardando (l’ultima guerra è stata nel luglio 2006, ci sono stati trenta giorni di bombardamenti), dobbiamo evacuare…». Mi chiedo: «Dov’è il punto di raccolta dell’ambasciata italiana? Come faccio a portare con me Emilio, che non ha passaporto italiano?».

Non è una semplice bomba, negli anni precedenti ne sono scoppiate, non è il rumore di un’auto fatta saltare in aria, come ogni tanto succede. È tutt’altra cosa. Il mio cellulare inizia a essere bombardato da colleghe e colleghi che scrivono sul gruppo di sicurezza: «Qui è crollato tutto, ma tutto bene…», «Anche qua sono saltate porte e finestre, ma noi stiamo bene». Se persone che vivono in posti così lontani della città mandano questi messaggi vuol dire che è successo qualcosa di grosso.
C’è un incendio al porto, si dice sia saltato in aria il figlio del presidente Hariri, c’è un’enorme confusione. Si capisce solo che si tratta di qualcosa di grosso. Trascorro ore angoscianti: vedo foto e video, la paura per colleghi, colleghe e amici, amiche cresce man mano che passano i minuti. Il mio appartamento diventa uno dei posti di raccolto e soccorso, aspetto che la macchinata degli sfollati di Beirut arrivi da me. Tutti i miei amici, parenti, conoscenti, iniziano a scrivermi. L’esplosione è avvenuta nel cuore della città, dove noi eravamo sempre, il porto è di fronte alla piazza principale di Beirut e tutti i quartieri occidentali che noi frequentavamo sono stati sventrati. Sale il terrore. Come stanno le persone che conosco, e poi, domani cosa si fa? Da dove ricominciamo? Provo un senso di sperdimento, di confusione, talmente grosso…
Vivo ore tremende. Finalmente, a tarda sera, colleghe e amici arrivano, pallidi, lividi, solo con i vestiti indosso, chi con uno zaino, chi ferito, stanchi, confusi, senza cibo. Occorre capire se i loro cari stanno bene – tra l’altro è saltata la linea telefonica – e una collega apprende che il suo fidanzato yemenita è gravemente ferito. È notte, le strade non sono illuminate, si sono letteralmente aperte, c’è acqua dappertutto, motorini sfrecciano tra le macerie per portare le persone ferite, dissanguate, negli ospedali che sono ancora in piedi (molti sono distrutti), il fidanzato della mia amica è operato in emergenza, è praticata una chirurgia di guerra, in condizioni di fortuna.
C’è un giorno di pausa, ma dal dopodomani (6 luglio) scendiamo in strada alle sei del mattino e andiamo ‘a passeggio’ tra le macerie… per me la cosa più sconvolgente è l’architettura urbana che ha cambiato forma, è tremendo; percepisco quanto noi viviamo circondati dal vetro, ci sono montagne di vetro, è esploso tutto, non ce n’è più nel paese, e queste montagne di vetro in frantumi rappresentano un pericolo mortale. Ricordo il rumore dei passi sul vetro, le linee curve dei palazzi. Poi, l’enorme risposta di solidarietà comune, siamo tutte e tutti, cittadini e cittadine comuni di Beirut e delle città vicine, insieme a sgomberare e pulire (il governo non si è fatto vedere), con scopa e paletta (tra l’altro in Libano non c’è un sistema di gestione dei rifiuti pubblico). Si avvia un fundraising in Italia. C’è una risposta solidale, coesa, molto bella: ricordo una grande sofferenza, ma anche un grande coraggio, giovani di tutte le fedi insieme…
Poi iniziamo le visite familiari per capire i bisogni delle persone… entrare nelle case e ascoltare le storie che raccontano è molto impegnativo sotto il profilo psicologico. Fa caldissimo, siamo in piena pandemia, Beirut è una città fantasma in mezzo ai rifiuti. Tremendo…
Che cosa è successo dopo? La popolazione si è spaccata perché la tragedia è stata politicizzata, il Libano ha rifiutato l’indagine internazionale e il processo è stato affidato a un giudice di buona fama, ma tutto è finito nella corruzione: quando il giudice ha iniziato a fare i nomi dei responsabili, che avevano stoccato nel porto tonnellate di nitrato di ammonio senza alcuna misura di sicurezza, quando ha iniziato a incriminare, gli sciiti lo hanno vissuto come un attacco alla propria comunità, ci sono state manifestazioni violente tra cristiani, sunniti e sciiti. Tutto è finito in nulla.

Quali progetti hai per il futuro?
Ho iniziato da poco a lavorare per UNRWA, vorrei continuare con questa agenzia per il prossimo paio d’anni. È un contesto molto diverso da quello di un’Ong, ho moltissimo da imparare, per consolidare la mia esperienza: è un ambiente molto internazionale, molto qualificato, nel quale ho la possibilità di lavorare con colleghi e colleghe di diversa formazione e competenza. Ora ho un contratto di consulenza, vorrei trovare il modo di entrare a far parte dello staff. Non escludo di fare un master, in un ambito di studi più vicino a quello che faccio adesso. Ho avuto una formazione generale, ora che ho imparato il lavoro sul campo vorrei approfondire qualcuno di questi aspetti di cui mi occupo con un percorso di studi. Non sarà, però, facilissimo incastrarlo con un lavoro full time.

Quali consigli daresti a una giovane che vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso?
Il primo consiglio è quello di essere curiosa e coraggiosa, sperimentare il più possibile, cercare esperienze di volontariato, studio, servizio, cominciare a capire se questo tipo di vita fa per lei, per le condizioni e implicazioni che comporta. E di muoversi sempre con organizzazioni riconosciute attraverso canali di sicurezza ben identificati: va bene esplorare, ma occorre farlo con cognizione di causa, ci sono già stati casi drammatici di rapimento di cooperanti italiane.

Per diventare cooperante professionale, per chi ha cittadinanza italiana, ritengo sia molto formativo il servizio civile all’estero: ci sono canali riconosciuti, strutturati, che permettono di fare servizio sul campo, con un inquadramento professionale importante per inserirsi nel mondo del lavoro con consapevolezza di quello che si fa. Per fare carriera alle Nazioni Unite, invece, ci sono diversi programmi per persone tra i venticinque e i trentacinque anni che permettono di entrare nella galassia Onu, anche dopo una laurea specialistica o il servizio civile. Infine, vorrei rivolgere alle giovani e ai giovani un grosso invito a non essere spaventati e a non sentirsi minacciati da quello che è diverso, a guardare al mondo con fiducia… Questo stile di vita, che è fonte di arricchimento, si può praticare non solo in Libano, ma anche in Italia, non c’è bisogno di fare scelte di vita radicali per rendere il mondo un posto più giusto, ciascuno, ciascuna può farlo nel luogo in cui si trova.
In copertina: Alice Boffi durante una missione nella valle della Bekaa, Libano, 2020.
***
Articolo di Laura Coci

Fino a metà della vita è stata filologa e studiosa del romanzo del Seicento veneziano. Negli anni della lunga guerra balcanica, ha promosso azioni di sostegno alla società civile e di accoglienza di rifugiati e minori. Dopo aver insegnato letteratura italiana e storia nei licei, è ora presidente dell’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.