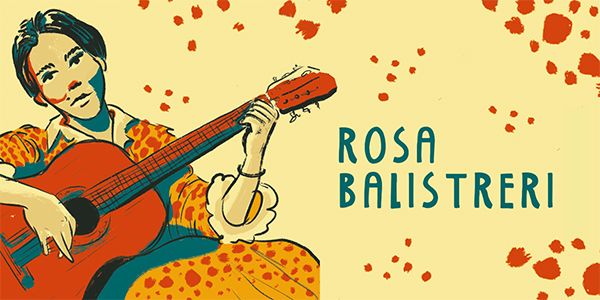La vita di Rosa Balistreri somiglia alla trama di un romanzo: sin da quando vide la luce, la sua esistenza fu un susseguirsi vertiginoso di eventi tragici, luttuosi che si alternarono a momenti di gioia e successi. Si stenta a credere che tutti questi avvenimenti possano essere stati vissuti da un’unica persona. Rosa è stata sicuramente una delle personalità femminili indipendenti più significative nella storia della musica popolare, di cui è stata interprete ma anche autrice, lasciandoci incise ben 120 canzoni. Alcune di queste ci raccontano la gioia delle festività natalizie o il dolore dei giorni della Settimana santa e della Crocifissione; altri sono testi politici, testi contro la mafia, per la maggior parte scritti da Ignazio Buttitta e Ciccio Busacca e da lei interpretati.

Suo il grande merito di aver riportato alla ribalta il patrimonio musicale della canzone popolare siciliana, frugando in un archivio che non ha documenti ma voci di popolo che raccontano usi, costumi, avvenimenti. Cantautrice e cantastorie: così viene definita, ma anche l’ “Amalia Rodriguez italiana” o “la Cantatrice del Sud”.
Era nata a Licata il 21 Marzo del 1917 da Emanuele e Vincenza Gibaldi e visse la sua infanzia nel quartiere Marina: un dedalo di vicoli e viuzze dove abitavano poche famiglie abbienti e la maggior parte della popolazione viveva una vita di miseria e di rinunce. Il suo canto, sin da ragazzina, si intrufolava tra quelle pietre antiche. Erano gli anni del regime fascista e dell’emigrazione di massa.
A sedici anni è costretta a sposare Gioacchino Torregrossa (Iachinazzu), un uomo violento, un ubriacone che venderà il corredino della figlia per saldare i debiti di gioco. A quel punto Rosa, accecata dalla rabbia e dall’esasperazione, aggredì e ferì il marito e per quella sua reazione, rubricata come tentato omicidio, scontò sei mesi di carcere. Non era certo stato un matrimonio d’amore. Il suo cuore aveva sussultato, prima, per il cugino Angelino e poi per Frank, un soldato americano ma lei era troppo povera, non possedeva dote per potersi sposare con chi desiderava. Erano aspirazioni irrealizzabili in quel tempo e in quel contesto.

Rosa, uscita dal carcere, svolse vari lavori: raccoglieva lumache, capperi, spighe, verdure varie e si impegnava nella salatura delle sarde per pochi spiccioli. Quando la assunsero in una vetreria, un giorno venne stuprata dal proprietario. Esasperata da quel destino avverso decise di recarsi a Palermo dove sistemò la figlioletta in un collegio e si ”mise a servizio” di una famiglia benestante, il cui rampollo squattrinato e indebitato per il vizio del gioco, la convinse ad avere rapporti sessuali.
Rosa restò incinta, lui le promise di non abbandonarla e la convinse al contempo a rubare dei gioielli alla madre per iniziare quella vita in comune. Ma era solo un vile stratagemma per pagare altri debiti di gioco.

Rosa, perseguitata dalla malasorte, trovò lavoro come custode della Chiesa Santa Maria degli Agonizzanti e dopo un periodo di relativa quiete, venne molestata dal nuovo prete che appena arrivato. A quel punto la misura è colma, Rosa ruba i soldi della cassetta delle elemosine e compra due biglietti di sola andata per Firenze: per sé e il fratello paralitico. In seguito la raggiungeranno gli altri familiari, anche loro decisi a recidere il legame con l’ingrata terra siciliana. In terra toscana la violenza del destino la colpirà duramente: sua sorella Maria verrà uccisa dal marito e il padre per la disperazione si impiccherà a un albero del Lungarno.

Dopo il dolore e la disperazione riuscì a reagire: aprì un banchetto di frutta e verdura nel quartiere San Lorenzo, e lì, negli anni sessanta incontrò il pittore Manfredi Lombardi. Nacquero così due grandi amori: quello per l’artista e quello per la chitarra. Tramite Manfredi si inserì nel mondo artistico e iniziò a cantare ammaliando i critici dell’epoca e i suoi nuovi amici intellettuali. Iniziarono i concerti: cantava in dialetto siciliano, cantava nelle Feste dell’Unità, con la sua voce graffiante in cui si percepiva la disperazione della vita vissuta, ma anche la dolcezza delle nenie della sua terra.

nipote Luca Torregrossa, autore del libro “L’amuri c’à v’haju”
Dario Fo la scelse per rappresentare la Sicilia in una rassegna. Fu un successo travolgente e i suoi concerti venivano richiesti non solo in Europa ma anche in America e in Australia. Incontrò in questi nuovi mondi milioni di emigrati che la acclamavano, la riverivano apprezzando quel suo timbro di voce quasi arcaico e primordiale.
Nel frattempo Manfredi l’aveva lasciata per un’altra donna e anche questa volta Rosa, dopo il grande dolore che l’aveva spinta al suicidio, reagì. Importanti anche le sue esperienze teatrali: non aveva alle spalle alcuno studio ma la sua autenticità era la chiave del suo successo. Debuttò a Firenze, nel 1968, con il Teatro stabile di Catania in La rosa di Zolfo e poi in altri spettacoli tra cui La ballata del sale, scritta appositamente per lei dal giornalista Salvo Licata. Reciterà e canterà anche ne La Lupa con Anna Proclemer e ne La lunga notte di Medea, con Piera degli Espositi.

Nel 1970 ritornò in Sicilia con la madre e il nipote Luca. Andò a vivere a Palermo circondata dai suoi amici, tra cui Renato Guttuso e Giuseppe Ganduscio. Partecipò anche a un Festival di Sanremo, ma all’ultima selezione venne esclusa. Non era facile comprendere il senso della sua voce straziata e straziante, frutto del suo tormentato vissuto, della sua sofferenza e della sua insofferenza, del suo grande orgoglio, della sua forza e della sua dignità. Così dichiarò dopo l’esclusione: «Ho deciso di gridare le mie proteste, le mie accuse, il dolore della mia terra, dei poveri che la abitano, di quelli che l’abbandonano, dei compagni operai, dei braccianti, dei disoccupati, delle donne siciliane che vivono come bestie… era questo il mio scopo».

Rosa è stata la voce della gente povera, anzi miserabile, delle ultime e degli ultimi fra gli ultimi, dei braccianti senza terra, dei minatori, delle donne stuprate e vittime di violenze. La sua era la voce di un popolo che reclamava il diritto a una vita migliore e a un lavoro dignitoso.

In particolare nella canzone Mafia e parrini (Mafia e preti) denuncia la sopraffazione degli ordini religiosi sulla povera gente, li definisce come delle sanguisughe; persone che nulla hanno da spartire con il senso autentico della sua religiosità. In molti testi è presente l’opposizione netta al fenomeno mafioso con denunce chiare e coraggiose: «La mafia disonora questa terra povera e onesta che vuole solo pane e lavoro, libertà e giustizia». Il canto di Rosa inquietava le coscienze: una voce scomoda per chi preferiva chiudere gli occhi e girare indifferente le spalle alla miseria e alla violenza di quel mondo da lei quasi gridato.
Dopo i successi ritorna anche nella sua Licata, ma non viene accolta con il calore che solitamente il pubblico le riservava. Era rimasta per le sue e i suoi concittadini, semplicemente “la moglie di Iachinazzo”. È morta a Palermo il 20 Settembre del 1990. Così dichiarò in un’intervista: «Si può fare politica e protestare in mille modi. Io canto ma non sono una cantante… diciamo che sono un’attivista che fa comizi con la chitarra».

Il suo grande impegno e il suo talento oggi sono ampiamente riconosciuti quasi a voler esaudire un suo desiderio espresso nella canzone Quannu moru: «Quando morirò pensatemi ogni tanto, perché per questa terra in croce sarò morta senza voce».
Qui le traduzioni in francese, inglese e spagnolo.
***
Articolo di Ester Rizzo

Giornalista. Laureata in Giurisprudenza e specializzata presso l’Ist. Sup. di Giornalismo di Palermo, socia Sil, collabora con varie testate on line, tra cui Malgradotutto e Dol’s. Per Navarra editore ha curato il volume Le Mille. I primati delle donne. Autrice dei saggi: Camicette Bianche , Donne Disobbedienti , Il labirinto delle perdute e i romanzi storici Le ricamatrici e Trenta giorni e 100 lire, sempre per Navarra editore.