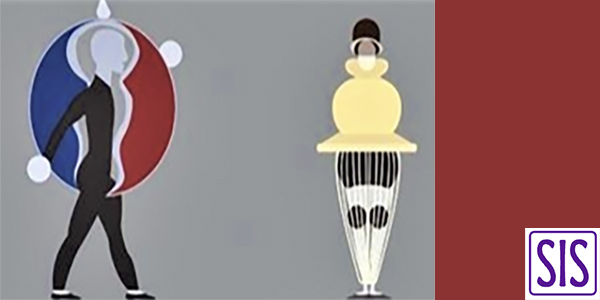Nel terzo incontro del corso online Migranti. Storie di vita, esercizi di relazione, organizzato dalla Società Italiana delle Storiche, Barbara Pinelli ha affrontato un tema cruciale: Politiche della frontiera, violenza di genere e memoria della violenza. Con oltre dieci anni di ricerca alle spalle, Pinelli ha analizzato il legame tra migrazioni forzate, violenza di genere e richieste d’asilo, mettendo in discussione l’uso strumentale del concetto di vulnerabilità nei protocolli umanitari. Al centro della sua riflessione c’è l’imperativo morale Women and Children First (“prima donne e bambine/i”), un principio non codificato ma profondamente radicato nella cultura occidentale, che rafforza l’immagine delle donne come fragili e bisognose di protezione. Questo paradigma, eredità del colonialismo e di tradizioni paternalistiche, si riflette ancora oggi nelle pratiche di soccorso e accoglienza. La vulnerabilità, osserva Pinelli, diventa un criterio di selezione nei regimi di frontiera: chi è abbastanza “vittima” da meritare protezione? Laddove il concetto viene reinterpretato in chiave politica da studiose come Judith Butler, nel contesto delle migrazioni forzate assume un significato opposto: per ottenere asilo, le donne devono esibire la loro sofferenza, persino attraverso prove fisiche delle violenze subite. Un sistema che, invece di proteggere, finisce per umiliare.
Un’altra variabile centrale è il silenzio. Le rifugiate che non parlano, che non si esprimono secondo le aspettative istituzionali, vengono percepite in maniera problematica. «Lei non parla», dicono gli operatori, senza considerare che il silenzio può essere una forma di resistenza o il risultato dell’impossibilità di tradurre il trauma in un linguaggio accettabile. Questa rigidità genera tensioni anche tra chi si occupa dell’accoglienza e le donne rifugiate. Chi si discosta dai canoni previsti rischia di essere vista come ingrata o inadeguata, ma dietro questo scontro si cela un conflitto più profondo: il modello occidentale di emancipazione contrapposto alla presunta inconsapevolezza delle migranti. Eppure, quando queste donne mostrano coscienza della propria condizione, vengono spesso delegittimate perché non usano il linguaggio “giusto”. Il paternalismo che permea le pratiche umanitarie ha conseguenze ben più gravi: le rifugiate vengono “espropriate” dalle loro culture, non permettendo di riconoscere le loro forme di resistenza e autodeterminazione: un approccio che non le sostiene, ma le ingabbia in schemi precostituiti da cui è difficile svincolarsi. Superare questa visione significa riconoscere la complessità delle loro esperienze, restituire agency alle donne migranti e smettere di considerare la vulnerabilità come sinonimo di passività. Solo così sarà possibile costruire un’accoglienza che non sia controllo, ma ascolto autentico.
Nel labirinto delle richieste d’asilo, non basta aver subito violenza: bisogna, così pare, raccontarla nel modo giusto. Le istituzioni continuano a cercare vittime che aderiscano a narrazioni predefinite e chi si discosta rischia di non essere creduta. Ma il dolore non sempre trova parole adatte, e il silenzio diventa un ostacolo insormontabile.
È in questo contesto che una testimonianza può diventare decisiva, ma può anche essere fraintesa. Una donna, spiega Pinelli, racconta di essere stata infibulata due volte perché la prima “non aveva funzionato bene” e, successivamente, stuprata dal cugino. Gli operatori/trici addetti alla sua situazione si sarebbero concentrati sulla ricerca di prove fisiche della seconda infibulazione, senza cogliere il vero significato del suo racconto: l’intervento, anziché proteggerla come imposto dalla tradizione, l’ha resa ancora più esposta alla violenza. Un altro caso emblematico è quello di una donna che, interrogata su cosa le accadrebbe se tornasse nel suo Paese, risponde con una frase enigmatica: «Per quelle come me c’è un nome». La sua risposta viene giudicata confusa dalla commissione territoriale che l’ha ritenuta incapace di articolare chiaramente la propria vulnerabilità. Eppure, dietro quelle parole si cela un destino segnato: a causa delle conseguenze dello stupro, la sua stessa esistenza è una condizione che a livello sociale si trasmetterebbe inevitabilmente anche alla sua progenie, condannandola all’emarginazione. Ma, poiché il suo dolore non è espresso secondo le aspettative istituzionali, viene ignorato.
Le istituzioni continuano a imporre modelli rigidi di testimonianza, incapaci di cogliere la complessità del dolore. Nel frattempo, le frontiere si chiudono e le risorse si assottigliano, creando un’accoglienza che oscilla tra il controllo e l’abbandono. Per superare questa rigidità, la nostra relatrice propone di sostituire il concetto di sistema di accoglienza con pratiche di cura al fine di sviluppare una cultura dell’accoglienza capace di gestire tali situazioni. Bisognerebbe riscoprire l’ascolto autentico, libero dai filtri burocratici che lo svuotano di significato. Alcuni esempi arrivano dalla Sicilia: numerose le storie che rivelano l’impatto crudele delle politiche migratorie. Giovani nigeriane, sopravvissute a violenze, vengono sottoposte a procedure accelerate che negano loro il tempo per elaborare il trauma, come quella di una madre e il suo bambino originari della Costa d’Avorio che, a causa di una separazione per motivi burocratici, hanno riportato conseguenze devastanti.
Un’altra testimonianza ancora riguarda una giovane donna nigeriana arrivata con il compagno e la figlia. La bambina, nata in una connection house (un luogo in cui le donne migranti vengono spesso trattenute e abusate, in Libia), aveva segni di gravi ustioni e il padre presentava cicatrici da torture. Dopo aver inizialmente parlato della sua esperienza, la donna è rimasta in silenzio per sei mesi, finché non è stata costretta a interagire con le istituzioni per iscrivere la figlia all’asilo. L’assenza di documenti vaccinali aveva portato a una serie di difficoltà burocratiche e, solo dopo un’attenta analisi da parte di un’operatrice, la verità: la bambina era nata da stupri ripetuti e la madre era stata completamente privata della possibilità di esercitare una qualsiasi forma di competenza genitoriale sul suo corpo.
La violenza sulle donne migranti non è solo episodica, ma si manifesta in forme continue e intersezionali, attraversando la dimensione fisica, psicologica, politica e sociale. E, soprattutto, non finisce ai confini. Continua nei centri di accoglienza, dove alle donne viene sottratta la loro cultura d’origine, considerata la causa della loro sofferenza. L’umanitarismo, con le sue buone intenzioni, spesso si trasforma in paternalismo, spostando l’attenzione dalle politiche migratorie ai presunti limiti culturali delle rifugiate. Così, mentre si predica il salvataggio, si perpetuano nuove forme di esclusione, velate, istituzionalizzate. L’apertura dei centri straordinari di accoglienza nel 2013-2014 ha aggravato questa situazione: più controllo sì, ma meno risorse. Le donne si muovono tra l’intrusione nelle loro scelte e l’assenza di un aiuto concreto, trovandosi in un limbo senza fine.
Le politiche di riduzione delle risorse hanno acuito il problema: la violenza di genere nelle migrazioni forzate non finisce con l’arrivo nei paesi ospitanti, ma si trasforma in nuove forme di sofferenza, tra separazioni familiari e mancato riconoscimento dei traumi.
La violenza non è un evento isolato, ma un processo che si prolunga nel tempo e nello spazio, modellando le identità e le relazioni delle rifugiate. Anche il silenzio istituzionale è una forma di violenza, che perpetua il ciclo della sofferenza.
***
Articolo di Nicole Maria Rana

Nata in Puglia nel 2001, studente alla facoltà di Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Appassionata di arte e cinema, le piace scoprire nuovi territori e viaggiare, fotografando ciò che la circonda. Crede sia importante far sentire la propria voce e lottare per ciò che si ha a cuore.