Tre anni dopo Il gioco dei regni, nel 1995, Clara Sereni pubblica un nuovo libro di racconti, Eppure, in cui ne confluiscono uno escluso da Manicomio Primavera e quattro già pubblicati su giornali e riviste.
Anche in questo caso la definizione di “raccolta” viene contraddetta dalla volontà della scrittrice di dare unità all’insieme, attraverso i raccordi tematici tra i diversi frammenti narrativi. Ma a fare di Eppure un vero e proprio romanzo è l’ultimo testo, un racconto lungo, La bomba, l’unico della terza sezione (intitolata come l’intero volume) che funge da epilogo. Qui i protagonisti dei dieci racconti che costituiscono le prime due sezioni si incontrano nella piazza centrale del paese, evacuati dalle loro abitazioni in attesa che si riesca a disinnescare la bomba dal potenziale catastrofico scoperta in una cava. Le persone che si trovano a condividere forzatamente uno spazio ristretto, e insieme la paura, il freddo, la fame, sono diverse per estrazione sociale, economica e culturale: malati e disabili, qualcuno “giù di testa” in seguito a un incidente sul lavoro, ma anche travestiti, spacciatori, barboni; o semplicemente anziani e bambini che l’età, rende non autonomi e dipendono da chi si occupa di loro, per familiarità o per lavoro.
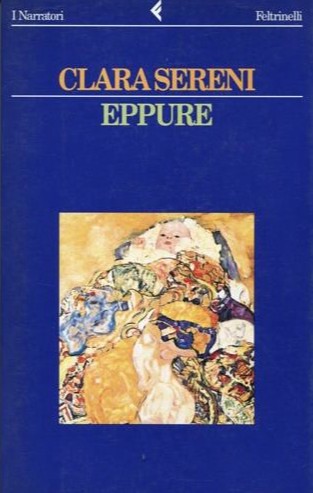
A fare da esergo al libro, Sereni sceglie stavolta una poesia di Pietro Ingrao, da cui trae i titoli delle due sezioni. Gli incolori raccoglie cinque storie di donne: donne anziane e bambine, le une e le altre condannate alla solitudine da figlie e madri incapaci di leggerne i bisogni e i desideri, o preoccupate di salvaguardare loro dai rischi del vivere e sé stesse da fatiche e grattacapi.
In Portami tante rose si affaccia la tematica dell’amore omosessuale: protagoniste una coppia di donne deluse nella speranza di poter finalmente portare alla luce dei riflettori televisivi una storia che è stato sempre difficile raccontare. Sull’ argomento torna La cloche di rafia nera, l’ultimo testo della seconda sezione, I semplici deserti, mentre il primo, Karaoke, descrive momenti della relazione tra una madre e un figlio disabile con accenti autobiografici che ricordano Casalinghitudine. Ritroviamo in questo libro l’interesse della scrittrice per i linguaggi alternativi capaci di offrire strumenti di comunicazione a chi si trova in difficoltà nell’uso di quelli abituali, come il cibo e soprattutto la musica: centrale già in Karaoke, ritorna in Parigi, a legare due coniugi in sedia a rotelle che non possono salire sullo stesso aereo per raggiungere la città in cui hanno sognato di festeggiare un loro anniversario.
Come i racconti di Manicomio Primavera, anche quelli di Eppure suggeriscono l’idea che la paura di varcare i confini della normalità nasca dal terrore di scoprire nell’incontro con l’altro qualcosa di sé che si preferisce ignorare. In maniera più esplicita lo dice il racconto finale della prima sezione, Ebrei, in cui una ragazzina di buona famiglia, di indole solitaria, rafforzata nel suo isolarsi da una madre cui non piace «il cortile, con quel confondersi di abitudini e parole» scopre con emozione l’amicizia: al liceo una compagna, cui si affida perché le sembra quasi una copia di se stessa, l’aiuta a ottenere voti migliori. Poco a poco le barriere sembrano sgretolarsi, le due ragazze diventano inseparabili, fino a essere soprannominate ‘le gemelle’ e l’intervallo dell’estate risulta difficile da vivere in solitudine; tanto che guardando dalla finestra con invidia le ragazzine del cortile, scalmanate e sudate, la protagonista non resiste e chiede di scendere anche lei; ma ne viene drasticamente dissuasa («non vorrai mica mischiarti con quelle lì») e si rassegna a riempire il tempo imparando «senza gioia, senza interesse, le abilità di sua madre». Quando arriva finalmente l’inizio del nuovo anno scolastico, qualcosa di sgradevole, e complicato da capire, si frappone fra lei e l’amica: «Poi Zarfati non venne a scuola né a casa sua per i compiti: un giorno, due, tanti. Quando tornò aveva un’aria seria sul viso che la faceva più grande […] confusamente e con imbarazzo disse di articoli apparsi sui giornali, di leggi, di politica, di preoccupazioni che avevano i suoi genitori: cose lontane, difficili, che lei non poteva pensare riguardassero la loro amicizia. No, proprio non poteva pensarlo. Per questo, quando lesse la paura negli occhi dell’amica la incoraggiò sull’interrogazione e la pagella: rifiutandosi a ogni sua altra preoccupazione. Fra loro scese un silenzio pesante, una distanza di cui non riusciva ad immaginare le ragioni».
Poco dopo la scomparsa definitiva della compagna, su cui la ragazza preferisce non indagare, viene vissuta come tradimento intollerabile e conferma dell’opportunità di erigere barricate intorno alla propria tranquillità: «Dalla scuola altri scomparvero, insegnanti e allieve. Senza clamori, e se vi furono commenti lei riuscì a non sentirli, presa da quel dolore soltanto suo. Però c’era qualcosa, nell’aria di novembre. Qualcosa che l’inquietava, un sospetto di spavento che attraversava le sue giornate e le rendeva inutile lo studio. Con una scusa e qualche fatica convinse sua madre ad accompagnarla nel quartiere dove abitava Zarfati. Proprio lì, vicino a via Arenula. Vicoli stretti e bui, muri che si stringevano verso l’alto, soffocanti per chi abitava in quelle case. I pochi passanti camminavano a testa bassa rasente i muri, frettolosi. Qualche voce di venditore, un richiamo: anche nei sussurri si percepiva una differenza, vocaboli incomprensibili e inauditi. La voglia di correre incontro a Zarfati, intravista attraverso il vetro di un negozio, sembra essere, per un attimo, più forte della paura della diversità; ma la ragazzina, trattenuta dalla madre, non ce la fa ad attraversare la soglia e le «parole incomprensibili: “Baruchù barushemà”…» di una filastrocca, che le arrivano dall’interno, rafforzano l’impressione del tradimento e la decisione di rinunciare ad avventurarsi verso l’ignoto».
Da quel momento la protagonista «fu bene attenta a che niente del genere le capitasse mai più. […] Un’accortezza diffidente la tenne sempre al riparo da ogni rischio. Le tinte tenui furono la sua scelta: per eleganza, diceva lei, preoccupata di contrasti eccessivi. […] Delle vite degli altri pensò di non doversi immischiare». La rivelazione delle ragioni del supposto tradimento dell’amica avviene molti anni dopo, in occasione di una merenda che la donna, ormai anziana, ha preparato per la nipote e una sua compagna di scuola. Ma questa rinuncia a un panino col prosciutto e dichiara come motivo un’appartenenza ormai non più inconfessabile: «Noi il prosciutto non lo mangiamo, siamo ebrei». Un sussulto nella memoria, un collegarsi di notizie che aveva allontanato da sé. Lo spalancarsi improvviso e abissale di una possibilità, una spiegazione, un motivo: le convinzioni e le difese di una vita intera messe in dubbio da una parola sola, ebrei. Per quella possibilità, che mai prima aveva accettato di considerare, in un attimo la vita le si confuse, cambiando di senso e di significato: la strada percorsa smarriva le proprie ragioni, e spuntava una voglia di colori vivi e solari, sconvolgente».
Ma basta un bicchier d’acqua perché la protagonista, «ancorandosi alle certezze di sempre» recuperi la sicurezza delle scelte che ha compiuto. Per difenderle, queste scelte, che le hanno regalato una vita incolore, ma tranquilla, la donna fa in modo che la nipote non rinsaldi il legame con la compagna e la guida sulla strada che la renderà simile a lei: «“Sai, disse, e la voce suonava saggia — non è questione, ma è sempre meglio non mischiarsi…”.
“Con chi?” chiese la bimba. “Con chi non conosci bene, non sai chi è: magari vai a incrociare abitudini differenti dalle tue, e puoi trovartene male”. […] “A me il prosciutto mi piace” disse la bambina, come concludendo un suo ragionamento, “però mi va bene anche il parmigiano”.
Lei sospirò, cercò le parole per raccontarle Zarfati, il tradimento, la sparizione […] “Il mondo è più complicato di come te lo immagini tu, e anche meno buono”. Sotto il peso di quella sentenza la bambina s’incupì […] Sulla porta, al momento di salutarsi, nonna e nipote si diedero appuntamento come sempre al giorno dopo, all’uscita della scuola: e se voleva far venire qualche altra compagna lei non avrebbe avuto difficoltà. Preoccupata di preservarla da ogni delusione, con un buffetto, la nonna come scherzando si raccomandò: “Ma non farmi impazzire con merende strane, siamo intesi?”».
Di grande modernità un altro racconto, Guaiti, estende l’attenzione al mondo degli animali e insieme sfiora un tema, quello dell’eutanasia, cui Sereni è sempre stata molto sensibile e su cui è intervenuta più volte pubblicamente.
Il protagonista è Paolo, un ragazzino che vive in una bella villa con giardino insieme ai genitori, alla nonna e a un numero imprecisato di domestici. Ma una malattia lo costringe su una carrozzella e a nulla valgono per renderlo meno triste le cure che tutti si affannano a prodigargli. In una casa in cui tutto è elegante e gradevole, dove ci si muove con discrezione e si parla a bassa voce, le scenate isteriche di Paolo, le sue continue richieste e gli orribili tutori che dovrebbero aiutarlo a camminare turbano l’armonia e rendono difficile da ignorare quel lato oscuro dell’esistenza, quella diversità irriducibile che l’agiatezza economica, l’intelligenza o i buoni sentimenti non riescono a sconfiggere. Di fatto tra i parenti di Paolo e il ragazzo è in atto una guerra, neppure troppo silenziosa: i primi tentano di tenere sotto controllo la situazione appellandosi alle regole, all’ordine, alle buone maniere e al buon senso, cercando di difendere come possono quella quiete che, insieme al decoro e al buon gusto, considerano il valore fondamentale. Lui si ribella con l’unica forza che ha, quella della malattia, alla sua stessa sofferenza e ai tentativi degli altri di fare come se non ci fosse. Popolano la vita di questa famiglia un buon numero di ‘esperti’ o ‘tecnici’. Regalare a Paolo una cagna non è, quindi, un’idea che nasca spontaneamente nel cuore di chi gli è vicino, ma il suggerimento di uno di questi. Quando Paolo fa «strane cose» che inducono una domestica a pensare a un tentativo di suicidio, l’ipotesi, troppo sconvolgente per esser presa in considerazione, è liquidata come fantasiosa; ma la nonna accetta di buon grado il consiglio dello psicologo che suggerisce un animale. Scegliendolo accuratamente, si potrà certo preservare igiene ed estetica, e una collocazione adeguata dovrebbe garantire la possibilità di tenere lontani dagli occhi e dalle narici degli umani quanto possa evocare la sua (e la loro) animalità. E all’inizio, come uno strumento sapientemente scelto, la cagna Asta funziona. Il controllo degli adulti sembra potersi finalmente allentare. La razionalità continua a rappresentare il criterio fondamentale cui affidarsi, contrapponendola alle leggi della natura, ma questa, come negli antichi miti, punisce chi si rifiuta di riconoscerne la forza: l’accorgimento chimico adottato per bloccare la fertilità dell’animale non basta a impedire che il caso (che assume le sembianze di un giardiniere disattento) porti scompiglio, disordine, sporcizia, e poi dolore in un mondo che da tutto ciò finora si è difeso tanto bene: un bastardo «rovina» la cagna. L’esperto di turno, il veterinario, non può che limitarsi a contenere il danno, quello igienico soprattutto. La malattia e la sofferenza s’installano definitivamente nel corpo di Asta, che, ormai incapace di portare allegria e movimento, diventa, come il suo padroncino, lamentosa e bisognosa di carezze. I suoi guaiti continui «mettono a dura prova i nervi di tutti», portando in casa irritazione, sconcerto, discussioni aspre. Ma «la forza della malattia e la minaccia delle scenate» di Paolo costringono i sani a contenere la loro insofferenza, che li porterebbe a sostituire subito la cagna malata con un altro animale: la nonna si è dichiarata disponibile ad acquistarlo, sborsando «una cifra anche consistente». I ruoli tra Paolo e la cagna sono ormai invertiti: è lui che la consola e la coccola, cercando di farle ritrovare l’amore per la vita e la voglia di giocare, stare all’aria e al sole. I due, legati dalla «comune difficoltà a vivere», si tengono caldo reciprocamente. Ma anche Paolo è costretto ad arrendersi: il suo amore, i suoi soldi, tutti gli esperti del mondo non valgono a nulla. E il bambino, che non ha potuto prendere per sé quella decisione drastica capace di porre fine alla sofferenza, in un ultimo e terribile gesto di amore, si assume la responsabilità di farlo per la cagna: con estrema tenerezza, senza ricorrere alla soluzione igienica, asettica, dell’iniezione suggerita dal veterinario, ma con un gesto drammatico e carico di sacralità, consapevole della necessità di sporcarsi le mani e di accettare la colpa, consegna il corpo di Asta alla vasca in cui si raccoglie l’acqua piovana da usare per i fiori.
***
Articolo di Gabriella de Angelis

Docente di latino e greco nei licei e nei corsi dell’Università delle donne Virginia Woolf, si è dedicata alla rilettura dei testi delle letterature classiche in ottica di genere. All’Università di Aix-Marseille ha tenuto corsi su scrittrici italiane escluse dal canone. Fa parte del Laboratorio Sguardi sulle differenze della Sapienza. Nel Circolo LUA di Roma intitolato a Clara Sereni, organizza laboratori di scrittura autobiografica.


